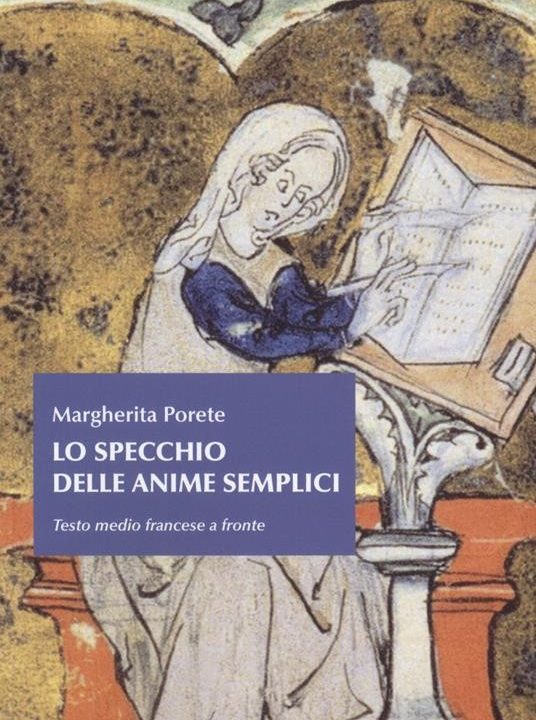Nell’ambito delle scienze sociali, sono sempre più numerosi gli studi dedicati alle “nuove élite”. Il termine “nuove élite” (al plurale) è attribuito in modo più evidente all’opera dello storico e critico sociale americano Christopher Lasch. Altri parlano di classe professionale-manageriale, una categoria che in parte si basa sull’idea di The Managerial Revolution (La rivoluzione manageriale) discussa da James Burnham già nel 1940. È interessante notare che, rileggendo 1984 di George Orwell, pubblicato per la prima volta nel 1949, ci si rende conto che la sua descrizione e critica del Partito, soprattutto nell’appendice, è in gran parte una critica di quelle che oggi potremmo definire più chiaramente le nuove élite moderne (o forse postmoderne). Stranamente, Orwell sembra essere ancora più attuale oggi di quando scrisse il libro.
Per Lasch, in uno dei suoi ultimi libri, la società doveva affrontare La rivolta delle élite. Con un titolo brillante, descrive un nuovo gruppo di persone che stavano distruggendo i propri valori e la propria società, da cui il sottotitolo: E il tradimento della democrazia. Il termine plurale “élite” è stato scelto con uno scopo preciso, come tutte le sue categorie precise. Non si trattava di un “establishment” o di una “classe” coerente, ma piuttosto di un amalgama molto più vago di persone in gran parte professionali che ora dominavano e gestivano le nostre istituzioni. L’idea di questa pluralità di élite era un’intuizione importante. Si trattava di una minoranza relativamente ampia di persone prive di una chiara ideologia o organizzazione, il che aiuta a spiegare la certa difficoltà nel cercare di definire con precisione con cosa e con chi abbiamo a che fare oggi. L’ulteriore difficoltà nel definire questo gruppo di persone, come ha osservato George Walden nel suo libro The New Elites: a Career in the Masses, è che essi si considerano, e in una certa misura sono (nel senso tradizionale del termine), anti-elitari.
Parte di questo corpus di lavori sulle élite include un altro americano, Alvin Gouldner, e la sua opera del 1979, The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class. Qui, come forse nell’appendice di Orwell intitolata “I principi della neolingua”, troviamo una discussione su come la “nuova classe” abbia un proprio linguaggio. In effetti, Orwell attribuiva una certa importanza al linguaggio e al nuovo tipo di linguaggio utilizzato dall’intellighenzia tecnica di Gouldner.
Quando lessi Gouldner, mi colpì molto l’enfasi che dava alla questione del linguaggio, ma non mi era chiaro cosa significasse o quanto fosse importante. Ora penso che ci siano due aspetti. Il primo riguarda il gergo tecnico e il linguaggio accademico, che sono specifici e diversi dal linguaggio “ordinario”. Il secondo, a mio avviso, è il fatto che le nuove élite considerano il linguaggio e il suo uso corretto molto più importanti di prima; il linguaggio è diventato, sotto molti aspetti, una cosa a sé stante.
Dopo il lavoro di Gouldner, ciò che è degno di nota non è tanto la specificità del linguaggio tecnico in sé, quanto il modo in cui questo, e più in generale il linguaggio e le categorie “corrette”, si sono espansi nella vita quotidiana.
In altre parole, se il linguaggio della nuova classe rimanesse all’interno dei suoi ambienti delimitati, nei luoghi di lavoro e nelle aree di competenza, il suo significato e il suo impatto sarebbero relativamente limitati. Tuttavia, parte del problema è che l’idea di competenza si è espansa verso l’esterno, tanto che quasi ogni aspetto della nostra vita è ora toccato da essa e dai termini e dalle categorie sviluppati dalla nuova classe, o più precisamente, dalle nuove élite.
L’idea di “esperto” ora include tutti i tipi di persone, come ad esempio gli “esperti” di genitorialità, mentre molti lavori di assistenza, dal lavoro sociale all’assistenza infermieristica e oltre, sono sempre più qualificati, il che significa che la formazione e il linguaggio utilizzato per classificare le persone e i comportamenti ora incorporano gran parte del nuovo linguaggio corretto. Grazie al declino del rapporto tra capi e lavoratori come struttura organizzativa dei luoghi di lavoro e alla conseguente ascesa delle risorse umane come base per la gestione di quasi tutta la nostra vita lavorativa, l’espansione del linguaggio politicamente corretto è diventata illimitata.
Inoltre, il significato del linguaggio per la nostra “classe” di esperti, si potrebbe persino dire la sua feticizzazione, è diventato sempre più importante. Di conseguenza, è emerso un nuovo tipo di “consapevolezza” delle parole stesse, qualcosa che viene imposto a dipendenti, studenti, clienti e così via in tutto il Regno Unito. L’ascesa e l’uso della “parola con la N” ne è un esempio calzante.
Ho sperimentato personalmente questa presa di coscienza circa 25 anni fa, dopo un diverbio con il responsabile dei servizi sociali del North Lanarkshire, che mi ha costretto a frequentare un “campo di addestramento” antirazzista. Il diverbio non aveva nulla a che vedere con il razzismo, ma questo non sembrava avere importanza. Ironia della sorte, come molte di queste iniziative, era gestito da un operatore che aveva perso il lavoro precedente e che non sembrava sapere molto di razzismo o antirazzismo. A parte me e un altro collega che ha messo in discussione le sue idee confuse, tutti gli altri si sono limitati a spuntare le caselle e imparare il copione. Sono stati resi “consapevoli”, o almeno sono stati resi consapevoli di questa cosa, la consapevolezza.
Più recentemente, ho completato la mia formazione semestrale sui pregiudizi inconsci: un’altra formazione online, relativamente incoerente, supportata da una serie di video con un test finale che anche un bambino di quattro anni avrebbe potuto superare.
Ripensando ai miei giorni come operatore giovanile e sociale a Coatbridge e Airdrie, ricordo di aver notato un cambiamento nel personale, che da operatori cristiani e socialisti più anziani, animati da una sorta di missione, era passato a operatori più giovani, apparentemente più professionali, che erano lì soprattutto per i soldi e per l’infinita possibilità di aumentare l’“autostima” dei clienti locali, che in gran parte cercavano solo lavoro o servizi migliori da parte del comune.
In alcuni dei lavoratori più anziani che erano entrati nel consiglio comunale e avevano intrapreso varie forme di assistenza, abbiamo anche riscontrato un cambiamento nel comportamento degli uomini, con un certo numero di ex operai siderurgici ed elettronici, ad esempio, che ora cercavano di imparare e adottare il nuovo modo di parlare ai loro “clienti” con “ascolto attivo”, “empatia” e “positività”.
Questo tipo di comportamento camaleontico si può osservare oggi nella maggior parte dei luoghi di lavoro. Lo si vede, ad esempio, nelle conferenze delle forze dell’ordine, dove si trovano le “vere” élite, spesso accademici e giovani membri ambiziosi dello staff che hanno un fervore per il modo corretto di pensare e di essere. E poi ci sono i poliziotti più anziani, spesso ufficiali di alto rango che seguono i fanatici, cercando disperatamente di ripetere a pappagallo il linguaggio più recente che indossano come una nuova armatura, anche se poco adatta.
Per riassumere, abbiamo un nuovo gruppo di persone che gestisce la società: le nuove élite. Hanno sviluppato un nuovo modo di parlare basato sulla competenza. Alcuni di loro sono fanatici, e molti sono yes man che hanno imparato il copione. Ma il significato di “esperto” si è ampliato, aiutato dalla massiccia espansione dei lavori “assistenziali”, dalla certificazione delle competenze e dalla formazione continua impartita dalle risorse umane. In questo modo, anche il grande pubblico, come lavoratori, clienti o genitori, è stato influenzato dalla specializzazione della vita quotidiana e dalla consapevolezza di “essere consapevoli”. Di conseguenza, il linguaggio e le aspettative implicite delle nuove élite del parlare (e del sentire) politicamente corretto stanno influenzando tutte le nostre vite.
Se volete avere un’idea del linguaggio delle nuove élite, l’intelligenza artificiale è un ottimo punto di partenza, poiché non solo fornisce i fatti corretti, ma spesso lo fa con una consapevolezza che la nostra classe pensante corretta incarna istintivamente. Chiedetele se esiste una “cultura dello stupro” nel Regno Unito, per esempio, e sarà come ricevere una lezione da una femminista vittima di violenza. Sì, ci dice, ci sono prove di una cultura dello stupro, di abusi “normalizzati” con la “colpevolizzazione delle vittime” e la “banalizzazione delle aggressioni sessuali”. Fornisce persino prove di un rapporto che evidenzia “la cultura dello stupro nelle scuole del Regno Unito”. A volte, l’intelligenza artificiale conclude anche con un messaggio morale e una parola sull’importanza di essere “consapevoli”.
Inizio con questa sintesi delle nuove élite e della loro feticizzazione del linguaggio, non perché questo sia il tema centrale di questo articolo, ma perché aiuta a spiegare, in parte, ciò che il politologo francese Olivier Roy chiama La crisi della cultura, che è ciò che voglio esaminare.
Per Roy, l’idea di una crisi della cultura non è che la cultura occidentale stia venendo sostituita da una cultura diversa, ma piuttosto che il significato stesso e persino l’esistenza della cultura siano minati; la società non sta affrontando una sostituzione alienante di una cultura con un’altra, ma piuttosto una “deculturazione”.
Aiutata da recenti sviluppi, come la globalizzazione, Internet e le migrazioni di massa, la tendenza generale verso una forma più profonda di iperindividualismo, sostiene Roy, è emersa dalla “rivoluzione” culturale degli anni ’60. Ora ci troviamo di fronte a un indebolimento delle nostre due forme di cultura, la cultura antica, alta (o elitaria), e la cultura antropologica quotidiana. È quest’ultima che mi interessa in questo contesto.
Sebbene in alcuni punti sia molto astratto, il lavoro di Roy è particolarmente perspicace quando parla dell’ascesa di una normatività implacabile. Con questo termine intende la specializzazione, la legalizzazione e la contrattualizzazione delle relazioni, attraverso le quali nuove norme vengono imposte, incorporate o adottate in sempre più ambiti della vita. Sono scomparsi i modi spontanei, comuni e istintivi di fare le cose e di interagire tra noi. Al loro posto, abbiamo l’ascesa di quelli che lui chiama “codici”: una vita gestita e amministrata attraverso codici di condotta e modi corretti di pensare, essere, comportarsi e parlare.
In parte, ciò che Roy descrive è ciò che il sociologo britannico Frank Furedi ha definito una “nuova etichetta della sicurezza” nel suo classico libro del 1997 Culture of Fear: Risk-taking and the Morality of Low Expectation. L’idea di una nuova etichetta è importante perché aiuta a spiegare come le idee politicamente corrette si sviluppano attraverso la gestione del nostro comportamento e delle nostre interazioni reciproche, ovvero come diventano, ogni giorno e ovunque, una nuova etichetta.
Con l’avanzare del processo di deculturazione, le tradizioni e le norme morali vengono problematizzate e decostruite. Infatti, quasi tutte le vecchie norme possono essere viste come oppressive: un’applicazione rigida di valori e doveri che limitano la libertà dell’iperindividuo. La “liberazione” del transgenderismo è solo un esempio di questo processo.
Lo sviluppo e l’adozione di questo nuovo modo di essere, osserva Roy, aiuta a spiegare perché i nostri nipoti si sono così distaccati dai riferimenti culturali dei loro anziani.
Da un senso generale e collettivo di ciò che è giusto e sbagliato (una cultura), secondo Roy, siamo passati a un nuovo sistema di regole, divieti e procedure burocratiche. L’ironia, sottolinea, è che con i nostri livelli sempre crescenti di libertà personale e il nostro desiderio di essa, abbiamo una codificazione sempre più ampia delle pratiche sociali che riduce gli spazi interiori, l’intimità, la privacy e persino l’inconscio. In sostanza, descrive un mondo in cui la responsabile delle risorse umane del lavoro è metaforicamente ovunque, controlla ogni nostra mossa e trasforma le nostre relazioni. In questo processo, minando (e burocratizzando) qualsiasi modo di essere radicato, sfumato e più umano, distruggiamo la libertà vissuta dalle comunità e miniamo la nostra capacità, come individui veramente liberi, di creare e ricreare la nostra cultura e la nostra società.
I valori non nascono più organicamente dalle persone, dalle comunità e dai paesi, ma sono imposti da élite scollegate, che utilizzano “codici”. Non trasmettiamo più la nostra saggezza o il nostro sapere popolare e non educhiamo più i giovani, in parte perché noi, come i nostri figli, abbiamo imparato il loro nuovo modo corretto di comportarsi. Abbiamo perso i nostri punti di riferimento culturali.
Ascoltate la voce del Parlamento scozzese dei giovani e ascolterete la voce purificata delle nuove élite, dove ogni casella della consapevolezza è spuntata con un virtuoso senso di scopo attraverso un linguaggio che qualsiasi pensionato della classe operaia troverebbe estraneo come una lingua straniera. E, naturalmente, questo “parlamento” di giovani è composto in gran parte non da individui politici, ma da identità.
Questo linguaggio colto è un linguaggio che spesso protegge e impedisce. Adula e gestisce le nuove identità, i frammenti che sono i punti di riferimento costanti di un gruppo elitario ed elitista sempre pronto a proteggere i vulnerabili. Qui troviamo le nuove élite più disconnesse, che non si pongono come rappresentanti della società, ma al di sopra e al di là di essa, guardandola dall’alto e gestendo i nostri “diritti”.
Come parte di questo processo di protezione e prevenzione, dobbiamo imparare a riconoscere queste identità frammentate, in gran parte perché mancano di un fondamento e di una profondità che possano dare loro una base sociale, morale e culturale stabile e coerente. Il rifiuto di riconoscere l’identità frammentata in questione viene inteso come un’altra forma di abuso. Il controllo e la gestione di questo processo, di queste persone (piuttosto che del popolo) conferisce alle nuove élite un senso di significato e scopo.
Senza una cultura comune, tutto deve essere gestito. Senza un senso di sé radicato nella società, il desiderio di “libertà” del singolo fragile individuo si accompagna a codici e forme di regolamentazione sempre più espliciti.
Ironia della sorte, anche se in qualche modo prevedibile, la crescita delle competenze specialistiche mina di fatto le professioni e la professionalità. Come ha osservato Philip K. Howard, critico giuridico e autore di The Death of Common Sense: How Law Is Suffocating America, in relazione al terreno sempre più vasto del diritto, con l’espansione delle norme, dei codici e dei meccanismi giuridici per gestire le relazioni, lo spazio per il giudizio, per i professionisti che utilizzano le loro competenze per valutare e prendere decisioni, è fondamentalmente minato. Le politiche di tolleranza zero prosperano e finiscono per rappresentare, in realtà, una discrezionalità pari a zero, senza alcuna capacità di pensare e di usare il proprio buon senso o la propria esperienza professionale per decidere sulle questioni. Di conseguenza, la capacità umana di negoziare, pensare e cogliere le sfumature viene sostituita dalla risposta demoralizzante dei “professionisti” che affermano “abbiamo una procedura” o “stiamo semplicemente seguendo la politica”, e così le “migliori pratiche” sostituiscono la professionalità viva e pulsante.
Un’ulteriore ironia, osserva Roy, è che in un mondo di autenticità, il sé autentico è soffocato dai codici espliciti su cui ha finito per fare affidamento. Come avrebbe potuto dire Sartre, le relazioni sono codificate in modo tale da convalidare gli attori in malafede. Sentiamo e ci convinciamo di agire in modo professionale e corretto, ma questo logora l’anima di chi lo fa quasi quanto quella di chi subisce questa relazione disumanizzante.
Con lo sviluppo della contrattualizzazione della vita quotidiana, anche gli ambiti più intimi della vita sono assoggettati a codici. Non sorprende quindi che gli studenti dell’Università di St. Andrews, e senza dubbio di molte altre istituzioni educative, debbano affrontare la gioiosa esperienza dei corsi obbligatori sul consenso. L’istinto e i rischi legati all’essere e all’agire liberamente non possono trovare spazio in un mondo privo di una cultura condivisa.
Le relazioni private sono ridotte a un insieme di regole, mentre un impulso autoritario prende il sopravvento su chiunque abbia istinti o inclinazioni diverse, il cui contro-discorso potrebbe, ad esempio, rifiutare la nuova forma di mascolinità corretta e addestrata che viene loro insegnata. Per Roy, la narrativa femminista che dagli anni ’70 ha sempre più caratterizzato la visione e la sensibilità delle nuove élite mira a smascolinizzare la percezione della sessualità e a creare così una nuova cultura della sessualità. In questo contesto, il comportamento tradizionale tra uomini e donne è caratterizzato da cliché e pregiudizi e si chiede di rifiutare e sradicare l’idea stessa di “virilità”.
Di conseguenza, la nuova formazione e istruzione, anche a livello inconscio, prende di mira la cultura antropologica o quotidiana come un problema, anzi come il problema, e viene confezionata attraverso il linguaggio della prevenzione e della protezione come un nuovo tipo di “libertà” sessuale. Come possiamo creare un tipo di relazione più contrattuale senza che sembri contrattuale? Come possiamo “cambiare la cultura”, come continuano a chiedere i nostri parlamentari scozzesi?
Il punto, tuttavia, è che questo non fa parte di una conversazione o di un dibattito, né si sviluppa attraverso il dialogo quotidiano. Non si tratta di una discussione, osserva Roy, ma di una prescrizione, aiutata dal “ripetere il mantra della tolleranza”. Non sorprende, quindi, che le varie campagne di sensibilizzazione che contribuiscono a diffondere la giusta sensibilità nelle scuole, nelle università, nei luoghi di lavoro (e oltre) debbano essere ripetute. A differenza dell’istruzione, che può essere acquisita con una lezione di sensibilizzazione, i cartelloni lampeggianti alle partite di calcio che invitano i tifosi a “dire no al razzismo” devono essere ripetuti all’infinito. Sembra che la mia formazione recente abbia rafforzato il mio pregiudizio inconscio, ma a quanto pare ne avrò bisogno di nuovo tra due anni e, presumibilmente, anche due anni dopo.
La tesi di Roy mi è venuta in mente durante una recente discussione seminariale con i miei studenti del secondo anno. Stavamo discutendo dell’idea della generazione più giovane “viziata” quando una giovane donna ha osservato che un asilo nido vicino a Dundee aveva una politica che vietava al personale di usare termini negativi come “cattivo”. Mi ha colpito il fatto che, se si analizza questo nuovo approccio, si possono identificare molti aspetti della crisi culturale. Molte delle cose che contribuiscono a creare e ricreare una cultura viva venivano minate da questa politica piuttosto insignificante. Ciò che veniva minato era l’autorità, l’autonomia e il giudizio.
Per generazioni, probabilmente durante tutta la storia moderna e persino premoderna, è stato semplice buon senso che quando un bambino fa qualcosa di sbagliato, glielo diciamo e spesso, istintivamente, usiamo il termine “cattivo”. In questo caso, noi, in qualità di genitori o professionisti che lavorano con i bambini, o adulti nella comunità, affermiamo una semplice norma attraverso la disapprovazione. In questo modo esprimiamo un giudizio e affermiamo la nostra autorità sul bambino, non come forma di “potere”, ma come parte del tentativo di buon senso di socializzare i bambini, basato in gran parte sulla nostra comprensione del ruolo degli adulti e del rapporto e della separazione che abbiamo con i bambini.
Attraverso il nuovo linguaggio terapeutico e la nuova sensibilità, tuttavia, questa forma di giudizio è considerata “inappropriata”. Il bambino, ora rappresentato attraverso il prisma della vulnerabilità, deve essere protetto dai giudizi negativi o anche dalla minima affermazione dell’autorità degli adulti. Alla base di questo approccio, direi, vediamo l’idea stessa di autorità degli adulti, un tempo radicata nella nostra cultura, essere ulteriormente problematizzata e minata.
Si tratta di una cosa minore sotto molti aspetti: è solo una parola, e nemmeno particolarmente dura. Ma qualcuno, da qualche parte, ha riflettuto sul significato di questa parola e di questo approccio e ha scritto una politica al riguardo. Questa viene poi insegnata al personale, che deve imparare a rifiutare sia il proprio buon senso che la propria esperienza professionale. Imparano a comportarsi in un certo modo e diventano “esperti” che ora sanno meglio dei genitori dei bambini, e anzi sanno meglio di tutte le generazioni passate, come parlare ai bambini. In un certo senso, mentre trasformano gli operatori dell’asilo in un nuovo tipo di esperti, gli operatori stessi perdono la loro autonomia, la loro personalità, le loro esperienze passate e professionali e il loro senso di giudizio più spontaneo e radicato.
Ad alcuni membri del personale questo sembrerà senza dubbio un po’ sciocco e privo di significato. Ma con l’aiuto dei loro superiori dal “pensiero corretto” (in particolare quelli più anziani e con una mentalità più elitaria o pomposa), il nuovo “codice” di comportamento diventa la “norma”. Quella che è essenzialmente una politica di tolleranza zero nei confronti delle critiche al comportamento dei bambini viene istituzionalizzata, e chissà cosa succederà al personale che si discosta da questo approccio. Ma almeno avranno senza dubbio a portata di mano il loro codice contro il bullismo e le molestie per affrontare tali deviazioni.
Naturalmente, è difficile sapere come questo influenzerà i bambini, ed è più importante considerare in che misura questo approccio non giudicante (o almeno meno giudicante) e “premuroso” sia diventato la norma in tutto il nostro sistema educativo.
In termini di norme comuni della società, forse è l’impatto potenziale che questo “approccio” proibito ha sui genitori e persino sui nonni che è più significativo e merita di essere considerato. Perché? Perché è probabile che questo nuovo modo di parlare e di relazionarsi con i bambini diventi noto ai genitori. Potrebbe influenzarli, ed è probabile che alcuni genitori sentano il bisogno di riconsiderare il modo in cui si relazionano, trattano e persino parlano con i propri figli. Altri potrebbero percepire un certo giudizio, se non sui propri figli, almeno su se stessi, qualora il personale venisse a conoscenza di determinate pratiche “scorrette”.
Questo “cambiamento culturale” è in gran parte anche il significato del divieto assoluto di sculacciare i bambini in Scozia, dove anche il più leggero schiaffetto sulla mano è stato criminalizzato. È improbabile che questa legge di sensibilizzazione porti a molti arresti, ma col tempo garantirà che a tutti noi venga insegnata la forma corretta di genitorialità secondo gli esperti.
A questo proposito, è interessante notare che chi ha promosso il divieto di sculacciare, come il parlamentare John Finnie, lo ha fatto con un certo entusiasmo morale, pur essendo un uomo che sculacciava i propri figli, ma che ora ha imparato a pensare correttamente. Lo ha fatto anche sapendo che la maggior parte della popolazione scozzese era contraria alla nuova legge, ma era proprio questo il punto, perché il neoilluminato Finnie e i suoi colleghi dell’élite erano espliciti sul fatto che ciò che stavano facendo era cambiare la cultura della Scozia.
Infine, non posso concludere questo articolo senza tornare sulla questione della cultura dello stupro nelle nostre scuole, un tema che mi è stato segnalato dal mio consulente per la consapevolezza sull’intelligenza artificiale. Nel caso ve lo foste perso, si tratta di una “ricerca” condotta da Everyone’s Invited. Quello che equivale a una sorta di rapporto #MeToo per bambini sostiene che la cultura dello stupro esiste in tutte le nostre scuole. Il lavoro è stato svolto da quella che definirei una vittima femminista, e ogni frase o termine è carico di questo punto di vista.
Ciò che mi ha scioccato della ricerca non è stato tanto ciò che diceva, ovvero che i bambini incarnano una cultura dello stupro, quanto il fatto che spesso commentatori e testate giornalistiche sensibili abbiano pubblicato i risultati senza mostrare alcuna preoccupazione per ciò che stavano facendo. Il Telegraph, ad esempio, ha pubblicato questi risultati nel marzo di quest’anno, sottolineando che quasi la metà dei bambini sotto i sette anni mostra segni di comportamento misogino e che queste norme di genere dannose sono radicate fin dalla prima infanzia.
Purtroppo, ciò a cui stiamo assistendo non è l’ascesa di bambini violenti, ma un mondo che sembra aver perso sempre più la capacità di distinguere tra adulti e bambini. Tutti i codici corretti, il linguaggio e la richiesta di una maggiore rieducazione delle norme sono presenti, e lo sono quando parliamo di bambini di appena tre o quattro anni. Categorie adulte, anzi categorie adulte accademiche, sui ruoli di genere e la misoginia vengono messe in bocca a bambini in un modo che solo dieci anni fa sarebbe stato inimmaginabile.
Non occorre certo essere Piaget o esperti di sviluppo infantile per capire che un’attivista femminista che parla di bambini di tre anni misogini riflette la perversione della sua immaginazione piuttosto che qualcosa, qualsiasi cosa, sui bambini che hanno appena smesso i pannolini. Il fatto che questo venga poi stampato, ristampato e discusso senza alcun senso di incredulità è un segnale molto preoccupante della misura in cui abbiamo perso sia il nostro buon senso che la nostra comprensione della distinzione tra età adulta e infanzia. Ma questo è ciò che accade quando iniziamo a perdere la nostra cultura, quando codici ansiosi e modi politicamente corretti di essere ci vengono prescritti da nuove élite scollegate dalla realtà.
Una madre nel nord della Scozia mi ha recentemente riferito che i servizi contro lo stupro e le aggressioni sessuali delle Orkney Islands (nelle Isole Orcadi, ndt) sono andati nella scuola di suo figlio per tenere una lezione sulla misoginia. Parte della lezione consisteva nello spiegare agli adolescenti che chiamare una ragazza “troia” è un esempio di “violenza sessuale”.
Man mano che il linguaggio diventa sempre più problematico e feticizzato dalle nostre élite e si diffonde attraverso i media e le istituzioni, sembra che avremo bisogno di costruire molte più prigioni, o almeno molti più centri di detenzione per bambini misogini “sessualmente violenti”!
Alla fine, quello che sembra un approccio premuroso che consente una maggiore libertà personale finisce per favorire il fiorire delle visioni più disumanizzanti e autoritarie.
Si tratta di qualcosa di inevitabile, perché le norme costruite dalle élite sono scollegate da noi e dalla nostra cultura. Sono essenzialmente un attacco alla cultura, al buon senso e all’autorità necessaria per educare i giovani. Ecco perché finiamo per pensare che la cultura dello stupro stia diventando sempre più un nuovo modo normale di vedere il mondo. Qui, la nostra stessa cultura è contaminata nel modo più osceno e irreale: noi, come società e come popolo, nel profondo del nostro essere, stiamo normalizzando lo stupro delle donne! O, come mi dice il mio amico AI, “Comprendere e affrontare la cultura dello stupro è fondamentale per creare una società più sicura e rispettosa”.
Siate consapevoli. La Grande Sorella ha parlato.
Detto questo, vale la pena sottolineare che esiste una distinzione tra i fanatici, le nuove élite e i loro messaggeri, che abbracciano questa deculturazione, e la maggioranza della gente comune, i miserabili.
Descrivendo la divisione culturale nella Gran Bretagna moderna, David Goodhart ha utilmente definito le nuove élite “gli Anywhere”. Scollegati dalla famiglia, dalla comunità, dalla nazione e da qualsiasi senso di significato collettivo o moralità, questo gruppo di individui isolati e nevrotici sono i veri iperindividui, i deboli Eloi, la borghesia futuristica e fragile descritta da H. G. Wells in The Time Machine.
È la loro mancanza di fede, la loro mancanza di cultura che li rende così nevrotici. Dove vedono un giudizio, “sei una merda”, non lo mettono in discussione con calma o ragione, ma sono pieni di orrore. Non è la natura gergale della parola che disprezzano, ma piuttosto qualsiasi forma di giudizio, qualsiasi cosa che vada contro la natura edonistica dell’individuo moderno e “vulnerabile”. Allo stesso modo, si sospetta che l’orrore per la misoginia (il panico moderno del nostro tempo) abbia meno a che fare con la realtà delle relazioni o con la consapevolezza dello stupro dei bambini, ma rifletta un orrore profondo per la forza e la capacità potenziali degli uomini e dei ragazzi della classe operaia, le masse muscolose che ancora non pensano o sentono allo stesso modo delle élite “femminilizzate”.
Il linguaggio è feticizzato dalle nostre élite. Dove noi vediamo termini crudi o giudicanti, loro vedono violenza. Dove noi vediamo il buon senso nel “rimproverare” un bambino, loro vedono un danno. Dove noi vediamo bambini che dicono e fanno cose sciocche, loro vedono gli adulti violenti del passato, del presente e del futuro. In effetti, il linguaggio stesso sembra avere più potere e creare più paura della violenza reale, e le persone vengono sempre più spesso rinchiuse, arrestate o intimidite dalla polizia, non per aver fatto qualcosa, ma per aver detto qualcosa. Si ha la sensazione che l’orrore assoluto che oggi proviamo per le parole non rifletta il danno reale che esse causano, ma la minaccia che rappresentano per le deboli élite e per il copione di consapevolezza che istintivamente sanno essere privo di qualsiasi qualità o profondità.
Per quanto ci provino, le élite amministrative e tecnocratiche non possono creare una nuova cultura. Che siamo in grado di creare la nostra volontà o meno, sospetto che dipenda da noi e dal fatto che “i miserabili”, “deplorevoli” abbiano un luogo e uno spazio dove far sentire veramente la loro voce.