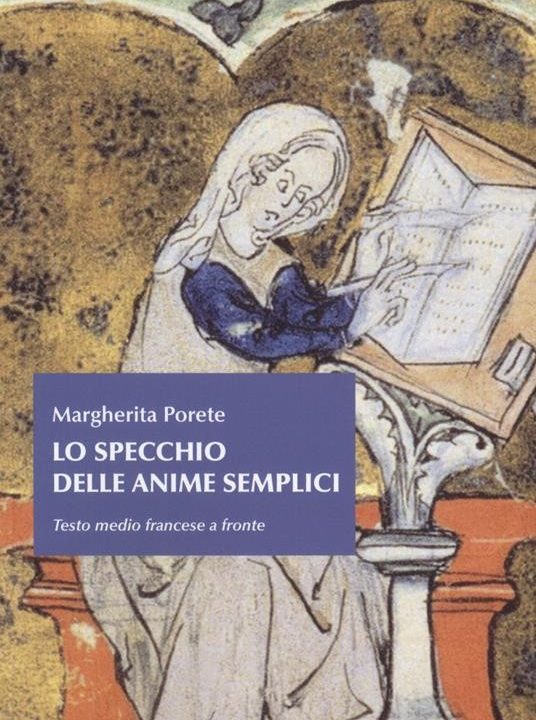Il pesce fa bene, si sa. È ricco di proteine e alcune specie (come salmone, sgombro, sardine, aringhe) di omega-3, motivo per cui è raccomandato da ogni nutrizionista.
Ma non tutto il pesce è uguale: quello proveniente da allevamenti intensivi solleva dubbi crescenti, non solo per l’ambiente, ma anche per la salute umana. Negli allevamenti industriali, infatti, i pesci vivono in gabbie affollate, con poco spazio e acqua povera di ossigeno. Per prevenire epidemie e parassiti, si fa ampio uso di antibiotici, antiparassitari e disinfettanti. Queste sostanze finiscono spesso nei sedimenti e, in parte, nei tessuti dei pesci stessi.
Uno studio pubblicato su Environmental Pollution ha rilevato tracce di antibiotici — chinoloni e sulfonamidi — nei mangimi e nelle acque di allevamenti ittici, con possibili ricadute sulla sicurezza alimentare. Un’altra revisione, su Public Health Reviews, avverte che i residui antimicrobici nei prodotti della pesca possono rappresentare un rischio inaccettabile per la salute pubblica, favorendo lo sviluppo di batteri resistenti agli antibiotici.
In Europa i controlli sono più rigorosi che altrove, ma non bastano a cancellare il problema. Il Piano Nazionale Residui 2022 del Ministero della Salute mostra che solo lo 0,07 % dei campioni è risultato non conforme ai limiti di legge, ma quasi la metà di questi casi irregolari proveniva proprio dall’acquacoltura.
In altre parole: il settore resta fragile.
Un’indagine condotta in Portogallo su spigole di allevamento ha trovato antibiotici come enrofloxacina e ossitetraciclina in un quinto dei campioni analizzati. Anche se i livelli erano bassi, l’esposizione prolungata a residui di questo tipo può contribuire, nel tempo, all’accumulo di sostanze indesiderate nell’organismo e — soprattutto — alla diffusione di resistenze batteriche, che rendono più difficile, poi, curare le infezioni umane.
Non è allarmismo, ma realtà documentata. “Conforme alla legge” non significa “innocuo”: i limiti di sicurezza indicano soglie, non assenza totale di rischio. E chi consuma spesso pesce allevato accumula comunque microdosi di sostanze farmacologiche.
Per questo, chi vuole tutelare la propria salute può orientarsi sul pesce selvatico, ma con discernimento: “selvatico” non significa automaticamente “più sicuro”, dipende da dove e da cosa si pesca.
Ad esempio, le aree costiere, le foci dei fiumi e le zone industriali sono spesso soggette a scarichi e inquinamento da metalli pesanti o pesticidi agricoli. Ma nemmeno gli oceani sono immuni: l’Atlantico è oggi uno dei mari con la più alta concentrazione di microplastiche, e le acque del Pacifico nord-occidentale restano parzialmente contaminate dagli effetti del disastro di Fukushima, con tracce di cesio radioattivo rilevate in alcune specie migratorie.
Anche la taglia del pesce è cruciale: più un pesce è grande e longevo (come tonno, pesce spada, verdesca), maggiore è l’accumulo di contaminanti lungo la catena alimentare. Le specie piccole e a ciclo breve, come alici, sardine e sgombri, sono generalmente più sicure e sostenibili: vivono meno, accumulano meno sostanze tossiche e provengono spesso da aree di pesca meno inquinate.
Concludendo, il pesce resta un alimento prezioso, ma la sua qualità dipende da come e da dove viene prodotto. Non prestare attenzione a provenienza e metodo significa trasformare la nostra tavola in un veicolo di residui e sostanze nocive.