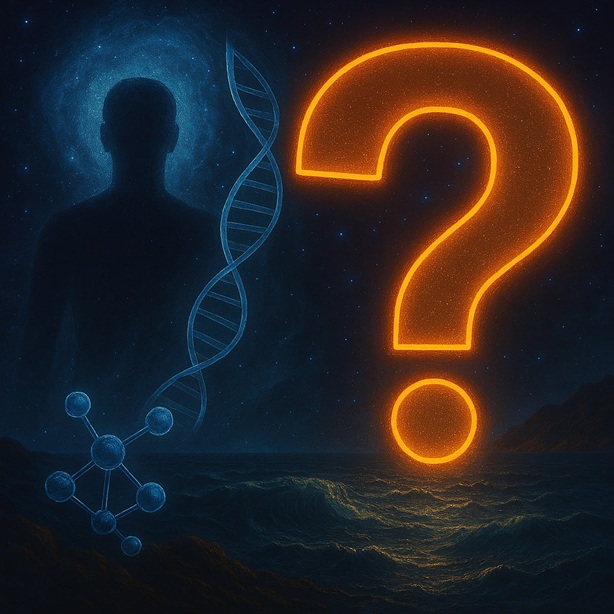Nel 2026, la politica interna degli Stati Uniti abbandona la logica del conflitto negoziabile per trasformarsi in una disputa cruda per il controllo effettivo dell’apparato di potere. La domanda centrale non è più quali politiche implementare, ma chi decide quando il dissenso politico cessa di essere legittimo e viene riclassificato come minaccia all’ordine. In questo slittamento, la figura presidenziale -incarnata in questo scenario da Donald Trump- si riconfigura: smette di essere un arbitro istituzionale per diventare il nodo centrale dell’attivazione coercitiva.
Il rischio reale non è quello dei carri armati che avanzano lungo i viali. Questo immaginario appartiene al XX secolo. La minaccia contemporanea è più discreta, più funzionale e, proprio per questo, più profonda: la codificazione progressiva dell’uso della forza federale come risorsa politica personale, un pulsante di panico sempre disponibile di fronte a qualsiasi crisi di governabilità. Non si tratta di una rottura spettacolare dell’ordine costituzionale, ma della sua silenziosa riprogrammazione.
Trump non ha bisogno di inventare questo dispositivo. L’impalcatura giuridica e amministrativa è già in piedi. L’Insurrection Act, la capacità di federalizzare la Guardia Nazionale, lo status speciale di Washington D.C., le competenze espansive delle agenzie federali e l’elasticità semantica di concetti come “ordine pubblico” o “sicurezza nazionale” costituiscono un repertorio storico pronto per essere attivato, forzato e normalizzato. La novità non risiede nello strumento, ma nel criterio politico del suo impiego: l’eccezione come prima risposta, non come ultima risorsa.
In questo nuovo quadro, il federalismo americano cessa di funzionare come sistema di equilibrio e diventa un ostacolo da aggirare. Gli Stati, lungi dall’essere contrappesi legittimi, vengono letti come giurisdizioni problematiche quando si discostano dalla linea dell’Esecutivo. Il conflitto non si svolge più tra progetti politici su un piano istituzionale condiviso, ma lungo un asse verticale: centro contro territorio, comando contro resistenza amministrativa. La domanda implicita smette di essere “che cosa dice la legge?” e diventa “chi possiede la capacità reale di imporre la propria definizione di crisi?”.
Washington D.C. funziona come il laboratorio ideale di questa mutazione. Non essendo uno Stato e priva di piena sovranità, rimane in un rapporto di dipendenza diretta dal potere federale. Qui, la presenza prolungata della Guardia Nazionale smette di essere una risposta a un’emergenza circoscritta e si trasforma in infrastruttura di controllo, in paesaggio stabile. L’eccezione diventa routine; la militarizzazione, ambiente. In termini spodocenici, non è più la crisi a giustificare l’eccezione, ma l’eccezione permanente a produrre una percezione continua di crisi, legittimando la propria esistenza.
Il conflitto con il Minnesota offre un’immagine nitida dello slittamento in atto. Il governatore Tim Walz, dotato di una propria legittimità democratica, incarna esattamente ciò che questo paradigma tende a erodere: l’autonomia politica subnazionale. Quando l’Esecutivo federale minaccia di intervenire, non lo fa soltanto per “ristabilire l’ordine”, ma per riaffermare una gerarchia di comando: quella del centro sulle periferie, dell’imposizione sulla mediazione.
Qui emerge un’intuizione chiave: nella grammatica del potere di Trump, la distanza tra un leader straniero ostile e un governatore recalcitrante si riduce pericolosamente. Non per confusione ideologica, ma per l’applicazione di una medesima logica operativa. Entrambi diventano ostacoli da neutralizzare, focolai di indisciplina che giustificano l’attivazione di meccanismi eccezionali.
Questo spiega perché politica estera e politica interna inizino a rispecchiarsi. Trump non governa l’esterno e l’interno con manuali differenti; reimporta metodi. La minaccia preventiva, la dimostrazione di forza come messaggio politico e la riduzione dell’avversario a problema tecnico di sicurezza filtrano nello spazio domestico. Il confine tra nemico esterno e opposizione interna diventa poroso per costruzione.
È qui che il quadro dello Spodoceno si rivela decisivo. Non assistiamo a un collasso improvviso, ma a un logoramento funzionale. Le istituzioni non vengono distrutte: vengono svuotate. La legalità non è sospesa: è applicata selettivamente. La democrazia non scompare: diventa un involucro legittimante di pratiche di comando sempre più concentrate e sganciate dal consenso. Il potere smette di produrre accordo e passa a gestire il disordine.
L’impiego dell’esercito non è un’anomalia, ma la pietra angolare di un’architettura di rovina governabile. Il pulsante di panico non è concepito per un atto definitivo, ma per restare visibile, latente, come promemoria disciplinante di dove risieda l’ultima capacità di definire e far valere l’eccezione.
Ma il “pulsante di panico” non opera nel vuoto. La normalizzazione dell’eccezione non esprime soltanto una volontà di comando: rivela uno slittamento più profondo, di natura strutturale. Quando la politica inizia a dipendere dalla coercizione latente, di solito è perché lo Stato non riesce più a governare attraverso mediazioni stabili. E quando l’eccezione diventa infrastruttura, è perché l’amministrazione -quella trama silenziosa che trasforma il potere in capacità effettiva- si sta deteriorando. In altre parole: la militarizzazione non sostituisce la governabilità; emerge quando la governabilità si disgrega.
Il fallimento dello Stato in America: dal pulsante di panico allo Stato fallito
Se il primo movimento del 2026 può essere descritto come la normalizzazione dell’eccezione -la disponibilità permanente della risorsa coercitiva per ridefinire il dissenso come minaccia-, il secondo movimento è ancora più decisivo: il deterioramento deliberato della capacità statale. La possibilità di attivare la forza federale, infatti, non sostituisce ciò che rende uno Stato tale: l’amministrazione quotidiana della vita sociale, la prevedibilità giuridica, la riscossione fiscale, l’erogazione dei servizi, la continuità burocratica e la riproduzione della competenza tecnica. Quando questa base si erode, la coercizione smette di essere soltanto uno strumento di controllo e diventa una toppa disperata. L’eccezione prende il posto della gestione; il comando tenta di occupare il posto dello Stato.
In questa transizione, il trumpismo non va letto come un’anomalia psicologica, ma come un acceleratore di una crisi di lunga durata: la trasformazione dello Stato federale in un territorio di conflitto interno permanente. “Ridurre lo Stato” non significa più riorganizzare funzioni, ma colpire le condizioni stesse che permettono a qualsiasi programma -di destra o di sinistra- di tradursi in politica effettiva. Senza personale competente, senza un’amministrazione efficiente, senza un minimo di stabilità normativa, nessun governo è in grado di realizzare in modo coerente il proprio progetto. La politica diventa performativa; lo Stato, incapace.
Qui emerge un paradosso sistemico: l’impulso autoritario, se intende consolidarsi, richiede un minimo di stabilità fiscale, amministrativa e giudiziaria. Nessun progetto di comando prolungato può reggersi su un apparato decomposto. Per questo, l’idea che politizzare e disciplinare l’amministrazione garantisca un controllo duraturo produce spesso l’effetto opposto: il caos. L’autorità non si decreta, si riproduce; e la riproduzione dell’autorità richiede istituzioni funzionanti, servizi erogati, salari capaci di trattenere competenze, procedure che generino prevedibilità. In assenza di questa base, l’autoritarismo non consolida l’ordine: moltiplica le disfunzioni, che ritornano sotto forma di ingovernabilità.
Da questa prospettiva, la militarizzazione e lo svuotamento del federalismo non sono “eccessi” all’interno di un ordine sano, ma sintomi di un ordine che non riesce più a sostenersi tramite mediazioni. Man mano che la polarizzazione diventa strutturale, l’amministrazione cessa di essere concepita come continuità e viene interpretata come nemica. Lo Stato si configura come bottino: ogni alternanza viene vissuta come epurazione, non come ricambio. In queste condizioni, l’apparato pubblico smette di garantire stabilità e si trasforma in un campo di battaglia. Il risultato non è soltanto inefficienza, ma fragilità sistemica.
Il deterioramento opera per accumulazione. Inizia con il blocco istituzionale elevato a metodo, prosegue con la politicizzazione della giustizia e si approfondisce con la delegittimazione ideologica dello Stato in quanto tale. Quando si afferma l’idea che lo Stato sia l’origine di tutti i mali, ogni falla amministrativa diventa conferma di questa tesi, e qualsiasi tentativo di ricostruzione viene letto come una cospirazione. Si innesca così un circuito autoalimentato: erosione della fiducia → indebolimento istituzionale → peggioramento delle prestazioni → nuova erosione della fiducia. La decomposizione non “arriva”: viene prodotta.
Questa spirale non può essere separata dalla sua economia politica. La globalizzazione percepita come minaccia, la precarizzazione territoriale, la disuguaglianza crescente e la guerra culturale agiscono come forze centrifughe che rompono il patto minimo. Quando il patto si spezza, lo Stato perde la sua risorsa più decisiva: l’obbedienza volontaria. Da quel momento, il sistema può stabilizzarsi solo in due modi: ricostruendo la legittimità attraverso istituzioni efficaci oppure sostituendo la legittimità con la coercizione. Il pulsante di panico emerge come surrogato: non risolve la crisi di governabilità, la amministra sotto forma di minaccia latente.
In parallelo, si consolida una convergenza che l’Europa -per convenienza o per cecità- ha spesso sottovalutato: l’intreccio tra crisi dello Stato e potere delle piattaforme. Mentre l’apparato pubblico si degrada, la Silicon Valley non concentra soltanto ricchezza, ma anche infrastrutture: comunicazione, commercio, dati, mediazione simbolica e circuiti di coordinamento sociale. Laddove lo Stato si ritira o diventa disfunzionale, la piattaforma offre soluzioni private. Ma tale soluzione non è neutrale: produce sovranità di fatto. Lo svuotamento dello Stato non genera “libertà”; produce uno spostamento del comando verso forme tecno-cesaristiche, nelle quali l’autorità si concentra in conglomerati sottratti a ogni responsabilità democratica.
Qui si manifesta il nucleo spodocenico: non la distruzione totale dell’ordine, ma la sua sostituzione con un ordine di residui. Uno Stato che perde capacità non scompare: permane come involucro. Un’amministrazione dissanguata continua a esistere formalmente, ma opera come rovina funzionale. E tuttavia, quell’involucro può restare utile a un progetto di comando: offre cornici giuridiche attivabili selettivamente e legittimazioni simboliche, mentre l’amministrazione reale si sposta verso reti private e coercitive.
In questo senso, lo “Stato fallito” non si presenta necessariamente con l’estetica classica del collasso. Può manifestarsi come combinazione di tre tratti: inoperosità amministrativa, coercizione intermittente e privatizzazione delle infrastrutture sociali. Lo Stato fallisce non perché “non esista più”, ma perché smette di adempiere alle sue funzioni essenziali. Quando la giustizia è percepita come fazione, il fisco si indebolisce, le agenzie perdono competenza e la fornitura dei servizi si degrada, l’ordine costituzionale si riduce a narrazione. E una narrazione, priva di apparato, non governa.
L’Europa di fronte al crollo del garante
Per l’Europa, questo non rappresenta un’inquietudine morale o mediatica, ma un problema strategico. Per decenni, l’architettura della sicurezza europea si è retta su un presupposto: gli Stati Uniti erano un attore stabile e prevedibile, dotato di un comando disciplinato e di una volontà di impegno di lungo periodo. Tale presupposto ha strutturato non solo la difesa, ma anche la politica estera, l’industria militare, l’intelligence, la logistica e la stessa psicologia della dipendenza. Se la crisi interna statunitense diventa strutturale, l’Europa si trova di fronte a una domanda potenzialmente esistenziale: che cosa accade quando il garante smette di essere tale, non per effetto di un ciclo elettorale, ma per un indebolimento sistemico?
L’impatto immediato sarebbe militare, ma quello più profondo potrebbe rivelarsi finanziario ed economico. La posizione degli Stati Uniti nel sistema monetario globale dipende tanto dalla loro potenza economica quanto dalla fiducia nella loro stabilità istituzionale. Un’erosione accelerata della capacità statale intacca tale fiducia: non perché il dollaro debba crollare automaticamente, ma perché il “rifugio” smette di apparire garantito. Per un’Europa altamente interdipendente, l’impatto sarebbe diretto: esposizione bancaria, attività denominate in dollari, dipendenze tecnologiche, vulnerabilità logistiche e fragilità regolatorie.
In termini spodocenici, l’Europa rischia di sperimentare il collasso del centro come un fenomeno di contagio. L’implosione non arriverebbe “dall’esterno”, ma dal nucleo stesso dell’ordine che l’ha finora contenuta. Si tratterebbe di un contagio duplice -militare e finanziario- ma anche tecnologico e culturale. La dipendenza europea dalle infrastrutture digitali statunitensi non è un dettaglio: è una vulnerabilità strategica di primo livello. Se il centro entra in una crisi cronica, la periferia alleata non resta protetta: viene trascinata al suo interno.
Da qui, la questione europea non può essere formulata soltanto come “autonomia strategica” in astratto, ma come resilienza sistemica: resilienza monetaria (capacità di assorbire gli shock), resilienza tecnologica (funzionamento senza piattaforme esterne), resilienza militare (dissuasione senza tutela) e resilienza istituzionale (rapidità e coerenza decisionale). Se Washington scivola verso uno Stato-involucro governato per eccezione, l’Europa non può aspettarsi che l’ordine postbellico si ricomponga per inerzia. Deve assumere l’ipotesi di un mondo post-americano non come slogan, ma come contingenza plausibile.
Dall’eccezione alla disgregazione
Il punto finale è severo, ma logico: il pulsante di panico e il fallimento dello Stato non sono fenomeni separati. Il pulsante di panico è la forma politica di uno Stato che perde la capacità di governare attraverso la mediazione. Il fallimento statale è la condizione materiale di un potere che, non riuscendo più ad amministrare, deve imporre. E quando tale imposizione si esercita su un territorio federale frammentato, il rischio cessa di essere esclusivamente istituzionale: può trasformarsi in una disputa per sovranità pratiche -polizia, fiscalità, logistica- tra Stati potenti e un centro indebolito.
Nel peggiore degli scenari, questa disputa non sfocia necessariamente in una secessione formale; può produrre qualcosa di più spodocenico: una frammentazione di fatto, un mosaico di autorità parziali, con enclavi di controllo e zone di disfunzione. Non un collasso totale, ma una continuità degradata: un impero che sopravvive tra i resti, mentre l’eccezione consuma lo Stato e l’amministrazione si riduce a memoria.
Se così stanno le cose, la domanda smette di essere soltanto che cosa farà il potere con l’esercito o con le agenzie federali. Diventa una domanda storica: che cosa accade quando un centro imperiale, incapace di sostenere la propria macchina amministrativa, comincia a governarsi mediante tecniche di eccezione, e quando quell’eccezione diventa portatile. È in questo punto che la storia degli imperi tardivi cessa di essere analogia e si fa struttura.
Epilogo: quando il centro impara dalla propria periferia
Se hai già il potere di amministrare, devi imporlo. Quando lo vedi in rovina, lo Stato è in rovina.
La storia degli imperi tardivi mostra una costante: il collasso non irrompe nel centro come una novità, ma come generalizzazione di tecniche sperimentate ai margini. La periferia non è soltanto il luogo del danno; è il laboratorio del futuro del potere.
L’Impero Romano lo comprese troppo tardi. Per secoli, le sue province di frontiera vissero sotto regimi di eccezione permanente -governatori dotati di poteri militari, occupazione armata continua, sospensione delle garanzie. Roma si percepiva come spazio di legge, mentre tollerava che in Britannia o in Siria l’impero funzionasse come una macchina di puro controllo militare. Quando la crisi fiscale e politica raggiunse il cuore, Roma non inventò nulla: importò al centro le pratiche sperimentate ai suoi margini. La militarizzazione della politica non fu una rottura, ma una generalizzazione.
L’Impero Britannico seguì una traiettoria analoga. In Irlanda, in India e in Kenya sviluppò un arsenale sofisticato di tecniche di controinsurrezione, sorveglianza di massa, detenzione amministrativa e impiego delle forze armate in funzioni civili. Tali pratiche vennero giustificate come “eccezioni coloniali”, necessarie per governare popolazioni considerate ingovernabili. Tuttavia, quando l’impero entrò in declino, quelle stesse logiche furono reimportate. Il conflitto nell’Irlanda del Nord non rappresentò un’anomalia metropolitana: fu la periferia a restituire al centro la violenza che quest’ultimo aveva esportato.
Il caso francese è ancora più eloquente. La guerra d’Algeria non si limitò a brutalizzare la colonia: riconfigurò lo Stato francese. Le tecniche di tortura, di intelligence militare e di controllo sociale sviluppate in quel contesto non scomparvero con l’indipendenza. Si infiltrarono nella metropoli, alimentarono la crisi della IV Repubblica e contribuirono a modellare l’architettura autoritaria della V. La Francia apprese nella propria periferia che l’ordine poteva essere sostenuto mediante la coercizione pura, e quella lezione fece ritorno a Parigi quando il consenso si esaurì.
In tutti questi casi, l’errore del centro fu identico: credere che l’eccezione applicata altrove non lo avrebbe trasformato al proprio interno. Ma la dinamica dello Spodoceno insegna il contrario: l’eccezione è portatile. Circola, si normalizza e, quando le condizioni lo consentono, si insedia nel cuore del sistema come nuova routine di governo.
Gli Stati Uniti percorrono oggi quello stesso itinerario con una fedeltà inquietante. Per decenni hanno applicato all’estero -e nelle proprie periferie interne- politiche di militarizzazione, occupazione amministrativa e gestione delle popolazioni sotto la bandiera della sicurezza. L’America Latina, il Medio Oriente, le comunità razzializzate e i territori privi di piena sovranità (come Porto Rico o Guam -entrambi territori non incorporati degli Stati Uniti, ceduti dalla Spagna dopo la guerra ispano-americana del 1898) hanno funzionato come zone di sperimentazione. Il centro politico e simbolico si è a lungo creduto immune.
Il 2026 dissolve questa illusione. Washington D.C., con il suo status politico incompleto, assume oggi il ruolo che un tempo spettava alle colonie: uno spazio in cui l’eccezione è tollerabile perché “non appartiene pienamente alla nazione”. Stati come il Minnesota, quando oppongono resistenza, vengono trattati come se avessero oltrepassato una soglia: da giurisdizione politica a problema di sicurezza. Il potere federale non improvvisa; applica dottrine di controllo già note e sperimentate altrove.
Per questo, il pericolo ultimo non è Trump come individuo, ma la maturazione di un’architettura di eccezione portatile. Gli imperi non collassano perché un leader abusa del potere, ma quando il sistema impara a funzionare senza limiti interni stabili. Quando il centro inizia a governarsi con le tecniche sperimentate nella propria periferia, il collasso smette di essere un’ipotesi futura e si trasforma in una condizione presente.
Lo Spodoceno americano non annuncia una fine spettacolare, ma una continuità degradata: un ordine che sopravvive non grazie alla propria vitalità, ma amministrando resti, gestendo la paura e normalizzando l’eccezione, finché il pulsante di panico smette di essere straordinario e diventa la modalità ordinaria di governo.
Il centro è sempre l’ultimo a riconoscere la rovina. Ma quando vi giunge, ha già dimenticato qualsiasi altro modo di esistere.