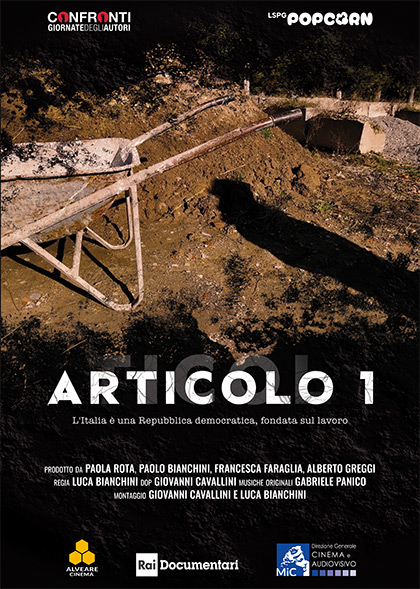Parigi, anni ’60. Esther, madre di una numerosissima famiglia marocchina da poco immigrata, dà alla luce il suo ultimo figlio, Roland. Il piccolo nasce con un piede torto che gli impedisce di stare in piedi, ma questo non scoraggia Esther dal combattere perché Roland un giorno possa camminare con le sue gambe. Contro il parere dei medici e del marito, che suggeriscono l’uso delle stampelle, Esther sacrifica tutto per realizzare il suo obiettivo e alla fine vince la sua battaglia: Roland imparerà a camminare, si iscriverà a un corso di danza, farà l’attore prima e l’avvocato poi, si sposerà e avrà dei figli e fra le altre cose lavorerà per la cantante Sylvie Vartan, in gioventù idolo di tutta la famiglia.
La storia è quella del vero Roland Perez, avvocato e giornalista radiotelevisivo francese: la sua autobiografia pubblicata nel 2021 ha lo stesso titolo del film nella versione originale, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan.
I tre protagonisti del libro – la madre Esther, il dio della tradizione ebraica (Perez viene da una famiglia di ebrei marocchini) e Sylvie Vartan, stella della musica pop francese nei primi anni ’60 – sono gli stessi del film, con naturalmente in più l’io narrante dell’autore, da adulto interpretato dal celebre attore francese Jonathan Cohen.
La madre è l’oggetto costante dei pensieri del figlio (la cornice del racconto è data proprio dall’inizio del suo lavoro di scrittura autobiografica) e il centro piuttosto ingombrante della sua vita. Nella prima parte la vulcanica Esther (a cui Leïla Bekhti offre anche da anziana la sua presenza energica) domina ogni immagine e accompagna col suo fare travolgente il tono da commedia scherzosa del film, evidente sia nel ritmo del montaggio (aiutato dal ricorso continuo a canzoni d’epoca) sia nelle atmosfere palesemente artificiose. Il piccolo Roland non prende quasi mai voce ed è una pura emanazione della madre, quasi il film sposasse un po’ ambiguamente il netto diniego dell’handicap da parte della donna.
Seguendo la tenace e un po’ ottusa battaglia di Esther (che vuole l’emancipazione del figlio in quanto lotta identitaria e non come conquista di un diritto, tant’è che rifiuta di mandarlo a scuola scontrandosi per questo con l’assistente sociale interpretata da Jeanne Balibar), il film abbraccia il modello narrativo della donna sola contro tutti (in particolare contro medici e intellettuali), finendo per esaltare la figura di una guaritrice (Anne Le Ny) che rifiuta di farsi chiamare dottoressa ma che cura il figlio…
Inevitabilmente, C’era una volta mia madre incarna un modello di società individualista, svelando le origini canadesi del suo regista Ken Scott (in passato sceneggiatore di successi come La grande seduzione) e scegliendo la via un po’ facile dell’identificazione immediata dello spettatore.