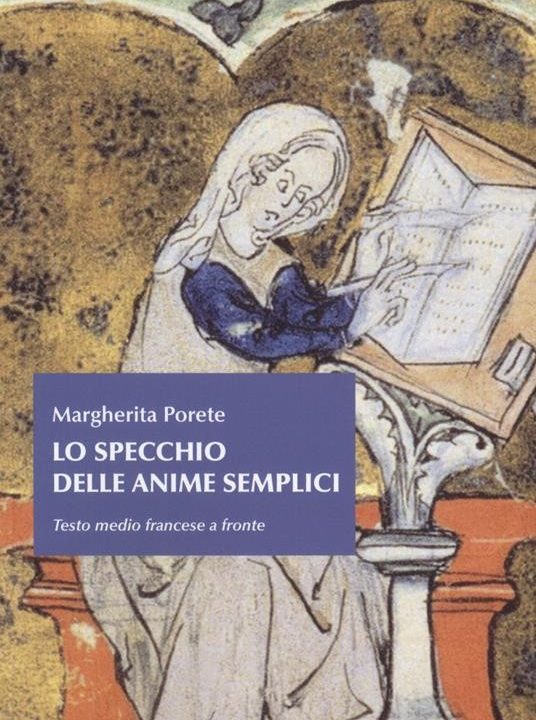Il dibattito sulla libertà vaccinale e sul ruolo delle istituzioni sanitarie è tornato d’attualità dopo il caso NITAG, il gruppo tecnico consultivo del Ministero della Salute che, a pochi giorni dalla nomina, ha escluso due medici noti per le loro posizioni indipendenti: Paolo Bellavite ed Eugenio Serravalle.
Una decisione che ha riacceso il confronto su un tema cruciale: quanto spazio c’è oggi per un reale pluralismo scientifico? Chi decide cosa può essere discusso e chi ha il diritto di farlo? E fino a che punto la scienza è ancora libera, quando diventa parte integrante delle strategie politiche e sanitarie di un Paese?
Con Paolo Bellavite, medico e ricercatore, autore di numerosi studi internazionali, affrontiamo le questioni più spinose: dai limiti del sistema di sorveglianza alle contraddizioni della legge sull’obbligo, dal ruolo dell’informazione alla responsabilità dei decisori pubblici.
Non per alimentare contrapposizioni, ma per restituire al dibattito quella profondità che ogni scelta di salute pubblica dovrebbe avere.
* * *
Professore, partiamo dal caso NITAG. Lei e il dottor Serravalle siete stati nominati e poi esclusi dal gruppo tecnico del Ministero. Cosa è accaduto e cosa rivela questo episodio sul clima all’interno delle istituzioni sanitarie?
“Il NITAG è un organismo consultivo del Ministero della Salute sulle strategie vaccinali, istituito a seguito di raccomandazioni dell’OMS, nell’ambito del ‘Piano d’azione globale sulle vaccinazioni 2011-2020’. Tale organismo dovrebbe indicare le prove scientifiche che sostengono le decisioni di strategia vaccinale, valutando l’attendibilità e l’indipendenza delle fonti utilizzate e verificandone l’assenza di conflitti di interesse. Senza nulla togliere agli altri 20 esperti nominati, si può pensare che le nostre nomine fossero un riconoscimento della politica al lavoro fatto pazientemente e faticosamente da tanti medici che si sono prodigati al servizio della società in momenti difficili mettendo a disposizione le proprie competenze. In particolare, il mio contributo in periodo pandemico è stato quello di suggerire le migliori cure della malattia in fase precoce (es. indometacina e nutraceutici, in gran parte confermati dalla letteratura successiva) e poi di descrivere le notevoli criticità dei nuovi ‘vaccini’. Ho collaborato con la Commissione Medico-Scientifica indipendente (CMSi) e pubblicato numerosi articoli di ricerca sulle riviste scientifiche internazionali e molti altri interventi di tipo divulgativo, tanto da acquisire stima internazionale e pure nell’ambiente della politica nazionale. Inaspettatamente, le nostre nomine hanno scatenato la reazione degli Ordini dei Medici, delle solite ‘virostar’, dei quotidiani mainstream e dei partiti di sinistra, più Forza Italia e ‘Noi moderati’. La pressione mass-mediatica e politica ha costretto Schillaci a fare retromarcia, a costo di una pessima figura per un Ministro, il quale, oltretutto, neppure si è degnato di comunicarci il motivo della nostra cancellazione.
Quanto è successo a Ferragosto nelle stanze del potere parrebbe assurdo, visto che il NITAG è un organo tecnico e avrebbe dovuto occuparsi anche delle criticità delle campagne vaccinali, argomento di cui sia io che Serravalle abbiamo competenza maggiore di coloro che ci hanno criticato. Ripensando all’accaduto, ho maturato la convinzione che il caso NITAG non dipenda solo dall’incoerenza di un Ministro, ma da un problema ben più ampio e drammatico: la questione dei vaccini è un punto nevralgico e cruciale di un ‘sistema’ costituitosi dall’intreccio di interessi tra politica, finanza e informazione. Il caso contingente in realtà rivela quanto le decisioni politiche dipendano dalle linee di organismi sovra-nazionali (OMS, WEF, UE, ecc.), i quali a loro volta sono condizionati da big pharma e dalla grande finanza (che a sua volta possiede big pharma). Rivela come la vaccinologia sia divenuta ‘vaccinismo’, quindi non una scienza ma un’ideologia, cioè una costruzione teorico-pratica al servizio del potere politico e finanziario, sostenuta da una serie di opinioni ‘credute’ da buona parte della classe medica e diffuse dal mainstream per ignoranza o per interessi degli operatori dell’informazione.
L’ideologia si presenta come indiscutibile ed è anzi divisiva. Chi non la accetta diventa un ‘No-vax’, un dissidente, un reietto, anche nella realtà pratica e professionale. Un dibattito scientifico è impossibile ed è rifiutato dai sostenitori del dogma vaccinista, tant’è vero che gli inviti ai convegni a tal scopo organizzati dalla CMSi e persino da università come quella di Torino sono stati sempre rifiutati o ignorati. Schillaci è solo una pedina di un gioco più grande, di cui fa parte il suo principale ‘sponsor’ Sergio Mattarella. Quel Mattarella che fu anche il principale sponsor della legge Lorenzin e non perde occasione per spingere le vaccinazioni e premiare le ‘virostar’. La scienza, con i suoi metodi di raccolta dati e i suoi calcoli di benefici e rischi, è annichilita da questo sistema.”
Molti operatori e le strategie vaccinali fanno riferimento alla cosiddetta “soglia di sicurezza del 95%” come parametro per l’immunità di popolazione. Lei la definisce un dogma politico più che scientifico. Può spiegare in che senso e perché ritiene che sia stata estesa in modo improprio a tutti i vaccini obbligatori?
“Innanzitutto, si deve fare attenzione a non confondere la reale o presunta efficacia dei vaccini con la questione delle ‘soglie di sicurezza’ per l’immunità di popolazione (altrimenti detta immunità di gruppo o di gregge). Che alcuni vaccini possano essere efficaci ed utili, in alcune età della vita, a prevenire le malattie infettive è un fatto acquisito, sancito anche dal fatto che sono messi a disposizione gratuitamente nei livelli essenziali di assistenza. Ricordiamo solo che, a livello individuale, va fatta un’accurata valutazione dei benefici rispetto ai rischi. Ma la soglia del 95% non c’entra con questo uso personale dei vaccini, essa si applica esclusivamente alla copertura vaccinale presunta come necessaria per fermare la diffusione dei microbi nella popolazione, cioè al beneficio che ne potrebbe trarre la ‘collettività’. Questi due termini della questione andrebbero sempre distinti, ma spesso sono confusi: il vaccino da bene individuale è assimilato a bene della società e quindi, nell’immaginario collettivo, chi non si vaccina diventa un ‘untore’, un potenziale pericolo per tutti. Si arriva persino a credere che chi non si vaccina possa essere un pericolo per i vaccinati, credenza ovviamente assurda ma ancora diffusa.
Se studiamo il problema dal punto di vista scientifico, scopriamo che la soglia del 95% non ha alcun fondamento epidemiologico o statistico: essa fu arbitrariamente indicata da un gruppo di ‘esperti’ dell’OMS (guarda caso!), senza alcuna prova che essa serva a bloccare o eliminare le malattie infettive. Si tratta di un valore empirico, stabilito per il morbillo (la più contagiosa delle malattie infettive dell’infanzia) dopo che percentuali inferiori si erano dimostrate inefficaci, poi esteso arbitrariamente a tutti i vaccini, solo per spingere al massimo le vaccinazioni. L’estensione a tutti i vaccini è connessa anche al fatto che per comodità e interesse le case farmaceutiche hanno progressivamente ‘accorpato’ molti antigeni in un’unica fiala.
Questo problema delle ‘soglie’ dell’immunità di gruppo andrebbe analizzato per ciascuno dei vaccini disponibili, ma qui non ce ne è lo spazio. In breve, i vaccini per difterite, tetano, pertosse, polio iniettivo, epatite B, non interrompono la catena dei contagi per ragioni tecniche legate al loro funzionamento e quindi non possono in alcun modo produrre un’immunità di popolazione. Il vaccino per Haemophilus influenzae di tipo b produce, di per sé, un effetto gregge ma ha causato un grave problema: quanto più la popolazione si vaccina, tanto più crescono i tipi batterici resistenti al vaccino, per cui le malattie invasive da Haemophilus in realtà sono aumentate dopo l’introduzione della vaccinazione a tappeto. Qualcosa del genere sta succedendo anche con la pertosse. I vaccini a virus vivi (morbillo, parotite, rosolia e varicella) potrebbero forse produrre un effetto gregge qualora, sommandosi all’immunità naturale, si arrivasse ad altissime percentuali di soggetti immuni. Però qui insorge un altro serio problema: poiché i virus attenuati dei vaccini non conferiscono un’immunità permanente (a differenza delle malattie naturali che immunizzavano per tutta la vita) e non tutti gli adulti sono propensi a farsi inoculare, si crea un “gap” immunitario nelle fasce di età centrali della popolazione. Gli adulti, che non avevano contratto le malattie da piccoli, ora si ammalano e possono diffondere i virus. Di conseguenza, una copertura pediatrica uguale o superiore al 95% non basta a eliminare le malattie infettive, visto che i virus continuano a circolare. Un’eccezione è la rosolia, malattia quasi estinta e per la quale esiste una forte immunità di popolazione da decenni, forse trasmessa anche per via materna, certo da ben prima dell’obbligo introdotto dalla Lorenzin.”
Fu l’allarme morbillo, nel 2017, a portare al varo della legge Lorenzin. Lei sostiene che quell’emergenza fu costruita in modo distorto. Può chiarire su quali dati si basa la sua critica e perché ritiene che quella narrazione sia stata funzionale a scelte politiche più che sanitarie?
“Il morbillo è la malattia su cui si accentrano le maggiori attenzioni delle autorità sanitarie e, sì, fu il principale argomento accampato per l’introduzione dell’obbligo vaccinale in Italia. Nell’ambito del già nominato ‘piano globale’ del 2014, il CDC degli USA scelse tale malattia come un ‘indicatore’ della bontà delle strategie vaccinali per un progetto della durata di cinque anni. L’obiettivo dichiarato era di raggiungere una copertura di almeno il 90% di bambini vaccinati entro i quindici mesi di vita in tutti i Paesi, con la speranza di eliminare la malattia stessa. Bisogna anche sapere che attorno al 2010 in Italia si era già raggiunta una copertura vaccinale pediatrica media del 90%, senza alcun obbligo.
A distanza di oltre 10 anni il morbillo è ancora presente anche in Nazioni altamente vaccinate, anche in Italia. La legge 119/2017 ‘Lorenzin’ fu voluta con decretazione d’urgenza nella primavera del 2017 sulla spinta di obblighi assunti a livello internazionale e con la scusa di un piccolo aumento di casi di morbillo. Tale fenomeno, ricorrente anche in altri anni, fu enormemente ‘pompato’ dalla politica e quindi dai mass-media: si pensi che l’incidenza massima si ebbe nella prima settimana di aprile con 4 casi per milione di abitanti (4/1.000.000!), di cui tre quarti adulti! Su base annuale, l’incidenza fu di 10 casi ogni 100.000 abitanti (a confronto, l’incidenza dell’influenza è di circa 10.000 casi ogni 100.000 abitanti). Ciononostante, la ministra Lorenzin, per gli accordi presi in USA, supportata dalla Federazione dei Medici e da Mattarella, voleva forzare ulteriormente le coperture pediatriche, utilizzando falsi allarmi diffusi da giornali e TV, ultimamente confidando nel ricatto dell’esclusione scolastica e nelle sanzioni agli inadempienti. Nel primo decreto-legge era inserita persino la perdita della patria potestà per chi non faceva vaccinare i figli! Eppure anche tale misura si è dimostrata inefficace nell’eliminazione della malattia e nel 2024 si è registrato un aumento fino a oltre 1000 casi. Stesso fenomeno si è registrato nel 2025 negli Stati Uniti: al 14 ottobre sono stati segnalati 1.596 casi confermati di morbillo in 44 focolai (gruppi di 3 o più persone con infezioni concatenate).
Un aspetto fondamentale dell’epidemiologia del morbillo è che l’incidenza non correla con le coperture pediatriche riportate dalle varie Regioni. Lo stesso problema si manifesta in altre nazioni. Ciò è dovuto al fatto al fatto che la malattia compare in forma ‘sporadica’, vale a dire non segue catene di trasmissione di tipo epidemico, e al fatto, già ricordato, che si ammalano soprattutto gli adulti, tra cui molti non sono vaccinati e non hanno contratto la malattia naturale.
In sintesi, il morbillo è stato usato ed è usato ancora per sostenere l’obbligo vaccinale, ma in modo strumentale e propagandistico. In realtà, l’immunità di popolazione non può essere raggiunta con l’obbligo di vaccinazione pediatrica nemmeno per il morbillo e quindi cade uno dei presupposti per la costituzionalità secondo l’articolo 32. Servono altre strategie, basate sulla libertà di scelta delle famiglie dopo corretta informazione, disponibilità di vaccini monocomponenti, predisposizione di immunoglobuline specifiche e studi su nutraceutici che rinforzano le difese immunitarie.”
Lei distingue spesso tra immunità naturale e immunità vaccinale, sostenendo che la seconda non garantisce la stessa durata. In che misura questo dovrebbe incidere sulle strategie di prevenzione e sulle politiche di obbligo?
“In uno studio condotto in Repubblica Ceca, dove le coperture vaccinali per morbillo sono elevatissime, si sono confrontate le sieropositività per morbillo in diverse fasce d’età. La sieropositività anticorpale più elevata, tale da garantire l’immunità duratura e con certezza, è stata rilevata nelle persone di età pari o superiore a 50 anni che erano state infettate naturalmente prima dell’introduzione di programmi vaccinali. La sieropositività più bassa (solo 61,5% di immuni) è stata registrata nelle fasce d’età 30-39 anni. Confrontando i tassi anticorpali (IgG) nella stessa fascia di età, essi erano superiori nei soggetti che avevano contratto la malattia naturale rispetto a quelli immunizzati tramite vaccinazione. Gli autori concludono che una protezione a lungo termine persiste dopo l’infezione naturale da morbillo, mentre diminuisce nel tempo dopo la vaccinazione.
Anche in uno studio recentemente condotto in Serbia si è documentata una notevole diminuzione di soggetti immuni al morbillo nelle fasce di età dai 30 ai 49 anni, mentre gli anziani hanno protezione completa. I bambini, nati nel periodo di incidenza bassa del morbillo e che quindi hanno acquisito immunità prevalentemente tramite la vaccinazione, hanno percentuali di sieropositività più basse degli anziani. Lo stesso problema è evidenziato da una analisi comparativa della risposta immunitaria a lungo termine al morbillo dopo l’infezione naturale o la vaccinazione di routine in Cina. Campioni di siero di bambini che hanno seguito il programma di vaccinazione di routine contro il morbillo e adulti che hanno acquisito l’immunità attraverso l’infezione naturale sono stati testati per gli anticorpi IgG contro il morbillo. I livelli anticorpali indotti dal vaccino scendono al di sotto della concentrazione protettiva già all’età di 15,8 anni, mentre i livelli anticorpali verso il virus del morbillo acquisiti naturalmente persistono per tutta la vita. Inoltre, gli anticorpi indotti dal vaccino nei bambini nati dopo il 2010, un periodo di bassa incidenza del morbillo, sono diminuiti più rapidamente rispetto a quelli nati prima del 2010. Questo è interpretato ipotizzando che, quando il morbillo circola in una popolazione, ne traggono beneficio come un “richiamo” anche coloro che erano stati vaccinati e rischiano di perdere l’immunità nel corso degli anni.
Alla luce di questi dati, una piccola circolazione del virus sembra avere un effetto positivo, perché contribuisce a mantenere attiva l’immunità della popolazione e desta ancora maggiori perplessità la pretesa di obbligare tutti a vaccinarsi. Considerazioni analoghe sono state fatte da vari autori anche per la varicella, una malattia non particolarmente grave se contratta in età infantile e che dà immunità permanente, ma potenzialmente molto grave se contratta in età adulta e anziana.
Il vaccinismo estremo diventa un boomerang per la stessa collettività. Quindi la strategia migliore sarebbe quella di abolire l’obbligo vaccinale pediatrico lasciando la scelta all’attenta valutazione del caso individuale da parte dei genitori consigliati da un pediatra che sia veramente libero di seguire la scienza e non i ricatti del potere o i guadagni. I pediatri di libera scelta dovrebbero essere retribuiti per l’attività di consulenza vaccinale, non per il numero di vaccini inoculati e non dovrebbero essere penalizzati se non vaccinano.
Un altro aspetto fondamentale, che avevamo in programma di proporre al NITAG, è quello della disponibilità di vaccini in forma di singola componente, da utilizzarsi per coprire particolari esigenze dei soggetti o della popolazione. Le persone dovrebbero poter scegliere di vaccinarsi solo per malattie verso cui non hanno già una immunità e il cui rischio esiste realmente. Inoltre, un vaccino monocomponente sarebbe molto utile per profilassi di emergenza e per delimitare eventuali focolai, vaccinando la cerchia delle persone entro 72 ore da un eventuale contatto con persona infetta. Purtroppo, le case farmaceutiche si sono accordate per fabbricare e vendere solo i vaccini complessi (MPR e MPRV), molto più remunerativi per loro, ma anche più reattogeni come effetti avversi del vaccino singolo.”
In un suo recente intervento ha definito il sistema sanitario “complesso e autoreferenziale”. Cosa intende e quali effetti produce questa autoreferenzialità sulla produzione e sulla comunicazione della conoscenza scientifica?
“Che sia un sistema complesso è evidente dal fatto che ci sono molte componenti tra loro intrecciate: tecniche, politiche, economiche, demografiche, ecc. e per di più in continua evoluzione. La politica decide chi finanziare acquistando farmaci e vaccini, decidendo chi privilegiare con incentivi, controllando anche l’informazione: si pensi a quanta pressione ha fatto il Governo finanziando chi fiancheggiava le campagne vaccinali. Ma i decisori politici italiani e europei sono condizionati dalle case farmaceutiche che pagano per la registrazione dei medicinali e dai mass-media che a loro volta influiscono sulle dinamiche democratiche.
Si è creato un ‘sistema’ autoreferenziale, costosissimo ed anche per questo difficile da intaccare, sostenuto dal paradigma tecnologico, collettivista e transumanista, più che dall’interesse per i bisogni della persona umana e che proclama, assurdamente, che la prevenzione delle malattie si faccia coi vaccini piuttosto che con l’igiene e la vita sana. L’autoreferenzialità è determinata anche dal fatto che nel corso degli ultimi secoli il sistema è cresciuto a dismisura, seguendo solo il pensiero cosiddetto riduzionista e meccanicista, che è prevalso nella medicina ufficiale per tanti motivi storici che qui non c’è lo spazio per analizzare. La medicina ha perso la sua caratteristica etica di ‘arte’ al servizio della persona umana, ma non è neppure una scienza compiuta. Essa è diventata una ‘téchne’, una tecnologia e, per l’invasione dello statalismo e dei condizionamenti economici, una prassi burocratica. Anche l’università è stata asservita a tale sistema e, anziché conservare la sua natura di produzione ed elaborazione del sapere critico, sistematico e integrato (da cui il termine ‘universitas’ del sapere), è divenuta un volano del pensiero unico dominante. Dalle scuole mediche escono laureati che dovrebbero, in teoria, seguire la scienza ma poi, in pratica, non riescono ad esercitare il mestiere e perdono il contatto coi pazienti, proprio perché la medicina non è ‘solo’ una scienza. Paradossalmente, quanto più è progredita la scienza, tanto meno la professione del medico ha mantenuto prestigio che aveva, decenni fa, agli occhi della popolazione.
Pochi lo hanno notato, ma il pressoché totale rifiuto dei vaccini Covid da parte degli italiani, nonostante le pressanti campagne, è tipico segno di tale paradossale fallimento. La figuraccia fatta dai medici di medicina generale durante la pandemia è un’altra prova di tale crisi: salvo lodevoli eccezioni, i pazienti sono stati abbandonati a casa senza cure, mentre i medici seguivano le ben note ‘linee-guida’ del ministro Speranza e la loro Federazione sindacale li difendeva. L’Ordine dei Medici, anziché tutelare la libertà di prescrizione, si è comportato come un servo delle direttive statali, arrivando a punire e radiare chi, nelle fila dei suoi iscritti, non si allineava.
Un vero cambiamento dovrebbe ripartire dall’etica medica, dal vero consenso informato, dal pluralismo delle conoscenze e delle prassi, valorizzando anche le medicine complementari, la libertà terapeutica in ‘scienza e coscienza’, svincolando la operatività del medico dalla pressione dello Stato e dalla pubblicità, diretta o indiretta, delle case farmaceutiche. Anche gli organi di informazione mainstream hanno una grande responsabilità nel fungere da amplificatori del vaccinismo, dando voce sempre alle stesse virostar.”
Nella sua analisi lei evidenzia come politica, industria e istituzioni sanitarie finiscano spesso per muoversi all’interno dello stesso perimetro di interessi. Può indicare episodi o dinamiche che, a suo giudizio, mostrano come questo intreccio abbia influenzato scelte cliniche, regolatorie o narrative durante gli ultimi anni?
“Del NITAG e della Lorenzin abbiamo già detto, come anche del fatto che le case farmaceutiche condizionano la cultura medica a partire dall’università. Personalmente posso ricordare il fatto che l’università di Verona mi ha ‘espulso’ per il solo fatto di aver criticato la farmacovigilanza italiana in una trasmissione televisiva.
Passando ad un altro campo, posso fare un esempio storico a riguardo dell’omeopatia, che conosco bene essendomici dedicato e avendo tradotto anche un libro al riguardo (‘Il simile in medicina’ di L.J. Boyd, Libreria Cortina editrice Verona). Nei primi due decenni del Novecento, l’Associazione Medica Americana (AMA) fece una guerra accanita contro l’omeopatia perché a quel tempo gli omeopati rappresentavano una valida concorrenza sul mercato della salute. Nel 1910 c’erano ancora 22 università negli Stati Uniti che insegnavano medicina omeopatica. La potente AMA ricorse ad ogni mezzo, ma il più efficace fu quello di penalizzare le università dove si insegnava omeopatia: fu commissionato un rapporto a un ‘esperto’ di nome Abraham Flexner, il quale raccomandò che fossero riconosciute solo le lauree delle facoltà dove si insegnasse le medicina ufficiale, i cui fondamenti teorici e sperimentali erano legati al paradigma chimico-farmaceutica. Questo mutamento fu spinto dai due magnati-filantropi John Rockefeller e Andrew Carneige, con grandi finanziamenti erogati esclusivamente alle scuole approvate dall’AMA e ai giornali medici che propagandavano i primi farmaci chimici che entravano nel mercato. Rockefeller e Carnegie dominavano rispettivamente le industrie del petrolio e dell’acciaio e furono figure chiave nello sviluppo industriale americano, prima di diventare filantropi di successo. Ovviamente, nel caso di Rockefeller la “filantropia” era anche un modo per finanziare il consumo di medicine fatte con l’industria chimica e di sintesi, se non proprio derivate dal petrolio.
È veramente curioso che certi miliardari finiscano col fare i ‘filantropi’ e cerchino di influire sulla cultura medica, arrivando fino a ‘comprare’ le riviste scientifiche! Purtroppo, chi ne fa le spese sono i cittadini che prima pagano il loro arricchimento e poi subiscono le deleterie conseguenze del fanatismo e di oscuri interessi. Facile pensare a un signore arricchitosi coi computer che oggi si spaccia per ‘filantropo’ e dice di salvare l’umanità coi vaccini (su cui lucra e fa lucrare i suoi amici tramite GAVI) e per far ciò finanzia abbondantemente la OMS e le università, tra cui anche quelle italiane.
La storia spesso si ripete e bisogna rendersi conto che il ‘modo’ con cui i malati oggi sono analizzati e curati ha tali radici storiche. Nel caso della pandemia Covid (su cui ancora non si è fatto un bilancio) l’intreccio tra potere e tecnomedicina è stato talmente forte da coinvolgere le massime istituzioni sanitarie nella ricerca sui virus letali e persino i militari. Sono stati i militari a sviluppare i primi vaccini, in previsione della pandemia da loro stessi considerata probabile, se non addirittura provocata. Una sequenza del virus SARS-CoV-2 è stata trovata in un brevetto di un vaccino di Moderna depositato nel 2016 e le probabilità che si tratti di una coincidenza sono di una su trecento miliardi. Eppure, sempre per rispondere alla domanda, succede che un’università italiana (Siena), con forti relazioni con la più grande multinazionale dei vaccini, conferisca la laurea ‘honoris causa’ a Tony Fauci, ritenuto uno dei responsabili del finanziamento ai laboratori di Wuhan da cui è ‘sfuggito’ il virus SARS-CoV-2.”
Tutti questi esempi, storici e contemporanei che lei ha fatto, mostrano quanto spesso le decisioni sanitarie possano essere modellate non solo dai dati, ma dal contesto di potere che li circonda. E quando questo accade, gli strumenti di controllo e verifica previsti dalla legge – quelli che dovrebbero garantire trasparenza e revisione critica – diventano ancora più cruciali. Anche perché, quando non vengono applicati, il sistema perde la sua stessa legittimità. Ed è proprio qui che nasce l’interrogativo successivo. La legge 119/2017 prevedeva una revisione periodica dell’obbligo vaccinale sulla base dei dati epidemiologici e della farmacovigilanza. Perché, secondo lei, questa revisione non è mai stata avviata, nonostante la stessa Corte Costituzionale ne abbia riconosciuto la necessità?
“La legge Lorenzin prevede una revisione dell’obbligo per i 4 vaccini a virus attenuati dopo 3 anni dall’entrata in vigore, in base alla situazione epidemiologica italiana e alle prove di effetti avversi, poi la Corte Costituzionale con la sentenza 5/2018 ha suggerito di effettuare la revisione dell’obbligo anche per gli altri 6 vaccini. Nulla è stato fatto. Esiste una finta ragione di tipo tecnico, basata sul fatto che le anagrafi vaccinali non sarebbero in grado di fornire realmente il numero dei vaccinati, ma esiste una ragione politica molto più forte: manca la volontà di toccare tale obbligo, inutile e dannoso per i bambini le famiglie.
Ribadisco a scanso di equivoci: non è inutile e dannoso il vaccino, che dovrebbe essere valutato individualmente, ma l’obbligo vaccinale.
Il principale ostacolo alla revisione della legge 119/2017 è rappresentato dall’ideologia vaccinista già sopra delineata, che ha permeato le istituzioni mediche ed è stata negli anni fortemente sostenuta dallo stesso Presidente della Repubblica. Il vaccinismo è sostenuto dai partiti di sinistra per ragioni ideologiche (vaccino come beneficio per la ‘collettività’) e da quelli di centro-destra (soprattutto Forza Italia) per i loro legami con il mondo farmaceutico-industriale. Si pensi che il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi), Andrea Mandelli è stato deputato di Forza Italia fino al 2022 e si adoperato per portare le vaccinazioni nelle farmacie e per promuovere l’obbligo di vaccinazione per l’influenza, assieme a Mariastella Gelmini (quest’ultima proposta fu respinta). Un’accanita vaccinista è la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, autrice anche di un disegno di legge per rendere obbligatoria la vaccinazione per il personale sanitario contro il SARS-CoV-2. Maurizio Lupi leader di ‘Noi Moderati’ ha approvato Schillaci e criticato pubblicamente me e Serravalle. Il vaccinismo ad oltranza è sostenuto, purtroppo, anche dalle organizzazioni mediche e soprattutto dalla Società di Pediatria. In tal caso si dovrebbe valutare la possibilità che un ‘incentivo’ possa essere costituito dai finanziamenti che le stesse organizzazioni ricevono dalle case produttrici di vaccini e che i singoli pediatri ricevono in proporzione al numero dei vaccini inoculati.
Ecco, quindi, i motivi della mancata revisione dell’obbligo vaccinale. Come a suo tempo l’obbligo vaccinale fu una decisione politica e non scientifica, così ancor oggi è sostenuto da una maggioranza trasversale di politici, per gli intrecci con big pharma e informazione mainstream si cui si è già detto. La ‘scienza’ è esclusa dal discorso.”
Lei denuncia da anni la mancanza di studi comparativi sullo stato di salute dei bambini vaccinati e non vaccinati. Perché questi dati sarebbero così importanti e quali ostacoli, scientifici o politici, ne impediscono la realizzazione?
“Gli effetti a lungo termine della vaccinazione sulla salute dei bambini rimangono praticamente sconosciuti, ma si presume che siano limitati unicamente alla prevenzione della specifica malattia mirata. Invece, esistono parecchie osservazioni empiriche e studi epidemiologici che suggeriscono che i vaccini provochino dei disturbi della salute dei bambini di tipo ‘aspecifico’. Sebbene gli studi randomizzati e controllati possano non essere fattibili, sono possibili altri progetti di ricerca, come studi comparativi su bambini vaccinati e non vaccinati. A parte alcuni studi che si riferiscono a Paesi africani in cui il vaccino difterite-tetano-pertosse ha aumentato la mortalità, soprattutto nelle bambine, esistono alcune ricerche che confrontano lo stato di salute di soggetti vaccinati con quello di soggetti non vaccinati. Ricercatori della Jackson State University (USA) hanno pubblicato uno studio che ha confrontato bambini vaccinati e non vaccinati secondo una ampia gamma di indicatori di salute. I bambini vaccinati avevano meno probabilità di quelli non vaccinati di aver avuto varicella e pertosse, ma più probabilità di aver contratto polmonite, otite media, allergie e disordini dello sviluppo neurologico.
Le autorità responsabili della salute pubblica potrebbero riflettere anche su questi aspetti strategici per il futuro e programmare ricerche comparative adeguate. Esaminando anche retrospettivamente i database dei bambini vaccinati e non vaccinati e seguendo nel tempo le coorti si dovrebbero poter individuare le eventuali differenze statisticamente significative tra i due gruppi. A questo proposito, è significativo il fatto che in USA dopo il cambio di ‘regime’ politico del 2024 stanno proliferando gli studi e le pubblicazioni che sostengono un legame tra eccesso di vaccinazioni infantili e comparsa dei disturbi del neurosviluppo, incluso l’autismo. Sostenere che i vaccini sono implicati nell’aumento della prevalenza di sindromi dello spettro autistico era una ‘bestemmia’ fino all’anno scorso, ora è diventato un argomento di ricerca, a ulteriore prova di quanto la medicina sia legata al potere politico.”
Molti cittadini danno per scontato che la farmacovigilanza sia pienamente funzionante. Lei parla, invece, di un sistema “passivo” e poco trasparente. In che senso, e che tipo di riforma sarebbe necessaria per restituire fiducia e credibilità ai controlli?
“A parole, tutti sono concordi sul fatto che la farmacovigilanza sia una componente essenziale delle strategie vaccinali, ma in realtà non funziona. Negli anni della pandemia ha funzionato ancora meno.
Innanzitutto, le segnalazioni degli eventi avversi sono in gran parte ‘spontanee’. Cioè, lasciate alla buona volontà, pazienza e disponibilità dei cittadini o dei pochi (e lodevoli) operatori sanitari che vi si dedicano. Pertanto, i ‘numeri’ che sono forniti nei rapporti AIFA, sia per i vaccini convenzionali che per quelli Covid, non hanno alcun valore in senso assoluto, se non in quanto consentono raffronti tra i diversi vaccini. Ad esempio, AIFA ha riportato circa mille decessi dopo i vaccini Covid (di cui ha riconosciuto come correlati solo una parte minima), ma non possiamo certo dire che i decessi reali siano solo mille. Possiamo solo dire che i vaccini contenenti sequenze modificate della proteina spike di SARS-CoV-2, a parità di dosi inoculate, hanno totalizzato duecento volte più segnalazioni di decessi rispetto a quelli dell’influenza.
Per restituire fiducia e credibilità sarebbe necessario attuare molti cambiamenti: a) la segnalazione di un evento avverso da parte degli operatori sanitari sarebbe già obbligatoria, ma mancano verifiche e sanzioni per chi la trascura; b) bisognerebbe potenziare gli studi di farmacovigilanza attiva e pubblicare i loro risultati, separatamente da quelli da vigilanza passiva anziché aggregati come assurdamente si fa oggi; c) per quanto riguarda l’analisi di correlazione, si dovrebbe applicare un metodo diverso da quello messo in funzione dall’OMS, secondo i criteri che io e altri autori abbiamo già spiegato in specifiche pubblicazioni anche internazionali; d) gli atti della Commissione che per AIFA ha studiato la mortalità dopo i vaccini Covid dovrebbero essere resi pubblici, fatte salve le garanzie di privacy per le vittime; e) bisognerebbe che tutti gli esperti e consulenti coinvolti nelle procedure di indennizzo per i danni da vaccino fossero realmente indipendenti, competenti e privi di conflitti di interesse.”
Durante la pandemia, numerosi ricercatori che sollevavano dubbi o chiedevano più prudenza sono stati marginalizzati. È cambiato qualcosa oggi, o la scienza resta un campo dove il dissenso è tollerato solo a parole?
“Mentre in USA la lezione della pandemia è stata recepita e ha portato a grandi cambiamenti, da noi sembra che non sia cambiato nulla. Là personaggi come Robert Malone e Jay Bhattacharya, che avevano criticato le strategie governative, sono stati messi alla testa di agenzie sanitarie governative (rispettivamente Direttore dei National Institutes of Health e the Advisory Committee on Immunization Practices), qua il NITAG è stato sciolto perché due membri su 22 erano contrari all’obbligo vaccinale e avevano osato sostenere – e con piena ragione – che nuovi prodotti biotech non danno immunità. Là Fauci è sotto inchiesta nonostante il perdono datogli da Biden con effetto retroattivo dal 2014, qua le virostar più in vista diventano onorevoli o sono premiati al Quirinale.
Per rispondere compiutamente all’interessante domanda devo precisare che nella scienza il ‘dissenso’ è un fatto normale, anzi è l’anima della scienza, che per sua natura cerca sempre il nuovo e archivia gli errori. Quello che succede, invece, è che la parola ‘scienza’ è usata quando serve a difendere lo status quo, mentre in realtà molte delle decisioni si giocano a livello del potere politico e economico, nel loro intreccio con l’informazione.
Un esempio tipico è stato le cure del Covid: il Ministero emanò delle linee guida in cui dichiarava che non c’erano cure se non sintomatiche (tachipirina) e che vitamine e quercetina non erano raccomandate perché non c’erano evidenze ‘scientifiche’. In nome della presunta ‘scienza’ negò l’uso di farmaci ‘off-label’ e ignorò le prove che venivano dall’uso ‘sul campo’. I medici che curavano diversamente erano considerati ‘dissidenti’, ma oggi sappiamo che, se guardiamo ai risultati di studi successivi dobbiamo concludere che i ‘dissidenti’ dalla vera scienza erano coloro che avevano emanato tali linee-guida!
Un altro esempio clamoroso di tale equivoco è il cosiddetto ‘Patto trasversale per la scienza’, un’organizzazione privata fondata non per fare ricerca scientifica, bensì per fare la lotta, nel mondo dell’informazione, a coloro che hanno posizioni scientifiche e politiche diverse dalle loro. Così è successo che costoro hanno accusato me e Serravalle di avere posizioni non scientifiche, ma senza spiegare quali sarebbero stati i nostri errori.
Il vero dibattito scientifico si dovrebbe svolgere non con le raccolte di firme o la pressione mediatica sull’opinione pubblica, ma con il confronto dei metodi, dei risultati e delle ipotesi. Così può succedere che anche le grandi riviste scientifiche si prestino a tali ‘giochi’ e privilegino certe pubblicazioni, rifiutandone altre.”
Lei critica spesso la comunicazione sanitaria, accusandola di semplificare e di spaventare invece di informare. Quali caratteristiche dovrebbe avere, secondo lei, una comunicazione scientifica onesta e rispettosa dell’intelligenza del cittadino?
“Non è facile. Il problema principale sta nel fatto che se pensiamo alle conoscenze scientifiche accumulate nel corso dei secoli e ora consolidate, esse sono divenute di dominio pubblico e sono insegnate nelle scuole. Ma se si pensa alle scoperte più recenti, agli argomenti di attualità, ecco che ci si trova di fronte non a delle ‘certezze’, ma a delle ipotesi, delle probabilità, delle posizioni diverse.
La scienza non proclama la verità, è più adatta a scoprire gli errori, questo sì. E l’errore più grande lo fa proprio chi dice di avere la verità in tasca, chi proclama dei dogmi, chi ripete come un pappagallo ‘efficacissimo e sicurissimo’, chi ostracizza a priori la teoria opponente.
Ciò vale in tanti campi oltre alla medicina, si pensi all’economia o al clima, ad esempio. Allora la prima cosa che dovrebbe fare chi comunica nel campo della scienza è quella di far capire ai lettori o agli ascoltatori che la certezza assoluta non esiste, che vi sono in campo diverse ipotesi. Inoltre, si deve far capire che la scienza è uno strumento di conoscenza, probabilmente il migliore, ma non è una variabile indipendente rispetto alla politica e all’economia, non ha uno ‘statuto speciale’ di indipendenza e assolutezza.
Purtroppo, questa posizione critica non trova spazio nei dibattiti televisivi o sui giornali, perché implica pazienza, prudenza, umiltà e non fa audience.”
Dopo questi anni di fratture e contrapposizioni, lei crede che sia ancora possibile ricostruire un dialogo serio tra cittadini, medici e istituzioni? Da dove bisognerebbe ripartire per restituire alla scienza credibilità e alla società fiducia?
“È fondamentale prima di tutto aver capito che questo dialogo si è interrotto a causa del circuito perverso tra politica, finanza e informazione, di cui il vaccinismo è la punta di diamante in medicina (in altri campi si potrebbe parlare anche del militarismo, i concetti generali sono analoghi). Bisogna prendere coscienza e diffondere la consapevolezza che siamo usciti da un periodo tragico e che bisogna trarne insegnamenti, cambiare rotta. Un po’ come successe dopo la seconda guerra mondiale, ripartire ma tenendo conto degli errori. Qualcosa di ufficiale si viene a sapere dalla Commissione Parlamentare Covid, ma ancora poco, lentamente e in modo tale che quanto emerge è facilmente insabbiato dai grandi circuiti di informazione.
Di fronte a tale sistema, è difficile individuare soluzioni e iniziative di ripartenza, però è anche possibile pensare che ‘qualunque’ azione in controtendenza possa avere risultati positivi per interrompere il circuito vizioso descritto. Certo non bisogna sottovalutare l’importanza che può avere l’azione, anche se apparentemente piccola, di ciascun cittadino che ‘resiste’, meglio se in forma di aggregazioni sociali e comunità.
Si può agire sul piano politico appoggiando persone, liste o partiti che operano per il bene comune a costo di essere in minoranza o emarginati. Si può agire sul piano economico-finanziario scegliendo di rivolgersi a medici che praticano una medicina personalizzata e complementare e consumare meno farmaci chimici, solo se proprio indispensabili. Si può fare attenzione, laddove possibile, a non sottoscrivere azioni di big pharma o industrie di armamenti.
Sul piano dell’informazione, che resta un nodo essenziale del sistema, si può cercare di sostenere gli organi di stampa o web indipendenti e diffondere le notizie tramite i social. Non si deve cessare di chiedere trasparenza sulle decisioni pubbliche, il contrario di quanto è successo con le contrattazioni miliardarie fatte dalla von der Leyen con Pfizer. Anche su scala nazionale e regionale, per recuperare fiducia nelle istituzioni è necessario che le decisioni siano prese da soggetti che non abbiano conflitti di interesse nelle materie trattate.
D’altra parte, pare difficile recuperare la fiducia nella scienza, perché il problema non sono i progressi scientifici, che sono dibattuti tra gli ‘addetti ai lavori’, ma i ritrovati tecnologici, per come sono usati da parte del potere e della propaganda. Tuttavia, bisognerebbe ancora continuare a sperare, pur ‘contro ogni speranza’, nella magistratura, nonostante si sappia che molte sue frange e persino i vertici sono funzionali ad un certo tipo di politica, che sostiene il sistema descritto. Alcuni recenti segnali positivi nell’azione di alcuni magistrati appaiono come luci nel buio, ma si sa che la luce, anche piccola, è sempre più forte dell’oscurità.”
L’intervista a Paolo Bellavite non pretende di offrire verità definitive, ma invita a una riflessione necessaria. La salute pubblica è un bene comune, e come tale richiede trasparenza, pluralismo e confronto, non adesione cieca né diffidenza preconcetta.
Forse il nodo non è più “vaccini sì o vaccini no”, ma chi decide, come decide e con quali garanzie di indipendenza. Perché solo una scienza libera da interessi e condizionamenti può essere davvero al servizio delle persone, non del potere.