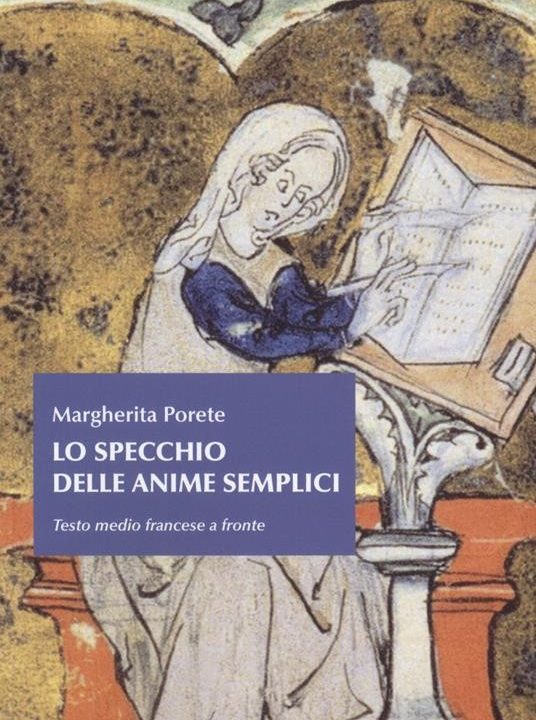Il 12 dicembre 2025, dal suo account su Truth Social, il presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, ha diffuso una dichiarazione che condensa una svolta storica nella grammatica del potere globale. In essa ha annunciato un blocco totale dei flussi petroliferi del Venezuela, ha rivendicato la proprietà statunitense sul petrolio sulla terra e su altri asset venezuelani, ha qualificato lo Stato venezuelano come organizzazione terroristica e ha presentato la coercizione militare, la confisca economica e la deportazione di massa come strumenti legittimi di governo. Non si è trattato di una provocazione retorica né di un gesto elettorale: è stata una dichiarazione pronunciata da un presidente in carica e va letta per ciò che è, una dottrina esecutiva in atto, in linea con quei momenti storici in cui il potere abbandona l’ambiguità e si enuncia direttamente.
La radicalità di questo messaggio risiede nell’abbandono della finzione normativa che ha sostenuto per decenni l’egemonia statunitense. Concetti come «leadership del mondo libero», «sicurezza emisferica» o «promozione della democrazia» — pilastri dell’ordine liberale del dopoguerra — vengono sostituiti da un vocabolario di contabilità e proprietà: asset, recupero, furto, restituzione. Il potere imperiale smette di nascondersi dietro istituzioni e narrazioni condivise per presentarsi nella sua forma più pura: quella del creditore che, con la forza delle armi, esige il pagamento di un debito la cui esistenza e il cui ammontare sono da lui stesso determinati. Non si tratta più di influenzare, disciplinare o tutelare, ma di appropriarsi. Il suo nucleo non è più l’influenza, bensì l’appropriazione; il suo linguaggio non è quello dell’ordine, ma quello del bottino.
Per oltre due secoli, la politica estera statunitense si è articolata attraverso dottrine che, pur essendo coercitive, conservavano una grammatica giustificativa. La Dottrina Monroe delimitò una sfera di influenza difensiva nei confronti dell’Europa; anche nella sua versione più dura, il corollario rooseveltiano, il linguaggio rimase quello della tutela e dell’ordine regionale. Gli Stati latinoamericani venivano trattati come attori subordinati, come spazi di intervento legittimo, ma non come occupanti illegittimi di risorse che un altro Stato rivendicasse esplicitamente come proprie.
La Dottrina Bush, formulata dopo gli attentati dell’11 settembre, radicalizzò l’uso della forza attraverso la nozione di guerra preventiva e di nemico diffuso, in sintonia con una concezione schmittiana dello stato di eccezione permanente. Tuttavia, anche allora, l’intervento continuava a presentarsi come difesa, come risposta straordinaria al terrorismo globale, come missione civilizzatrice. L’appropriazione materiale esistette — in particolare nel caso iracheno — ma venne sistematicamente negata sul piano discorsivo. Il saccheggio non poteva essere nominato senza mettere a rischio l’architettura morale dell’ordine internazionale.
Il memorandum Wolfowitz, elaborato nell’immediato dopoguerra fredda, introdusse una formulazione più esplicita fissando come obiettivo strategico la prevenzione dell’emergere di qualsiasi concorrente globale. In esso si rese manifesta la logica dell’unipolarità, ma ancora all’interno di un registro geopolitico classico: si parlava di primato, di stabilità sistemica, di deterrenza strutturale. La legalità internazionale veniva strumentalizzata, come avevano già osservato i critici dell’ordine tardo-westfaliano, ma non abolita come principio operativo.
L’amministrazione Biden ha tentato di ricomporre questo ordine eroso attraverso un multilateralismo tattico fondato su alleanze, sanzioni coordinate e retorica dei diritti umani. È stata una gestione del declino con forme istituzionali, un’egemonia amministrata che ha cercato di preservare regole selettive in un mondo sempre più multipolare. Il potere continuava a operare attraverso procedure e consensi formali, anche quando questi si facevano via via più fragili, come ha mostrato la proliferazione di sanzioni extraterritoriali e la finanziarizzazione giudiziaria della politica internazionale.
La dottrina enunciata da Trump nel dicembre 2025 rompe con questo impianto storico. La mutazione non è meramente ideologica, ma strutturale. Quando afferma che «il nostro petrolio» e «la nostra terra» si trovano in Venezuela, rovescia il principio fondamentale della sovranità territoriale. Non si tratta più di violare la sovranità di un altro Stato; si dichiara che tale sovranità, su determinate risorse, non è mai esistita. Il diritto internazionale non viene violato: viene dichiarato irrilevante. La sovranità si rovescia. La legalità si subordina all’annuncio presidenziale. Il blocco, che nel diritto internazionale classico costituisce un atto di guerra, viene presentato come una misura amministrativa ordinaria. L’eccezione si normalizza e diventa metodo.
Questa dottrina porta inoltre al suo estremo logico la securitizzazione totale della politica. Nemico (il «regime illegittimo» di Maduro), territorio (i giacimenti petroliferi «rubati»), popolazione (i migranti trasformati in «armi» di un governo ostile) e risorse (il petrolio che «finanzia il terrorismo») si fondono in un’unica massa indifferenziata di minaccia. I migranti venezuelani cessano di essere soggetti di diritto o vittime di una crisi e diventano strumenti di una guerra per procura, la cui contropartita è la deportazione di massa come rappresaglia geopolitica.
Le implicazioni di questa enunciazione sono profonde. Sul piano regionale, essa costringe i paesi dell’America Latina a un allineamento privo di sfumature, erodendo decenni di diplomazia dell’autonomia. Per gli alleati tradizionali di Europa e Asia, proietta lo spettro di uno Stati Uniti imprevedibile che strumentalizza l’ordine che afferma di difendere. I principali attori con interessi in Venezuela, come Cina e Russia, vedrebbero un blocco come un’aggressione diretta ai propri investimenti e alla propria influenza, con un elevato rischio di escalation. Sul piano interno, si stabilisce un pericoloso precedente costituzionale fondendo, in un unico gesto presidenziale, politica estera, guerra e politica migratoria, concentrando un potere esecutivo privo di contrappesi.
Questa svolta non è una semplice eccentricità dell’ex presidente Trump. È il sintomo di una fase avanzata di esaurimento sistemico. In un mondo segnato dalla competizione per risorse scarse, dalla crisi energetica e dalla frammentazione dell’ordine multilaterale, il potere egemonico, incapace di continuare a produrre consenso, abbandona la gestione del sistema e adotta la logica del saccheggio amministrato. Non costruisce più istituzioni per il futuro, ma mobilita i propri resti — la potenza militare, la centralità finanziaria — per estrarre valore dal presente. La politica estera smette di essere un’arena di disputa sul senso e diventa una logistica della confisca in uno scenario sempre più post-egemonico.
Da questa prospettiva, il quadro concettuale dello Spodocene consente di cogliere la profondità del cambiamento. Lo Spodocene non designa il caos, ma l’ordine che emerge quando il progresso si trasforma in rovina e la politica si riduce alla gestione del saccheggio. Lo Stato non si presenta più come garante dei diritti né come architetto di un avvenire comune, ma come impresa armata di recupero patrimoniale. Il mondo diventa inventario; la guerra, logistica; il diritto, residuo normativo.
La dichiarazione del dicembre 2025 va dunque letta non come una minaccia isolata, ma come un sintomo storico: il momento in cui l’imperialismo statunitense smette di giustificarsi e si enuncia senza mediazioni normative. Non siamo di fronte alla fine del potere, ma alla sua forma nuda. Nello Spodocene, governare non significa più ordinare il mondo, ma appropriarsi di ciò che resta.